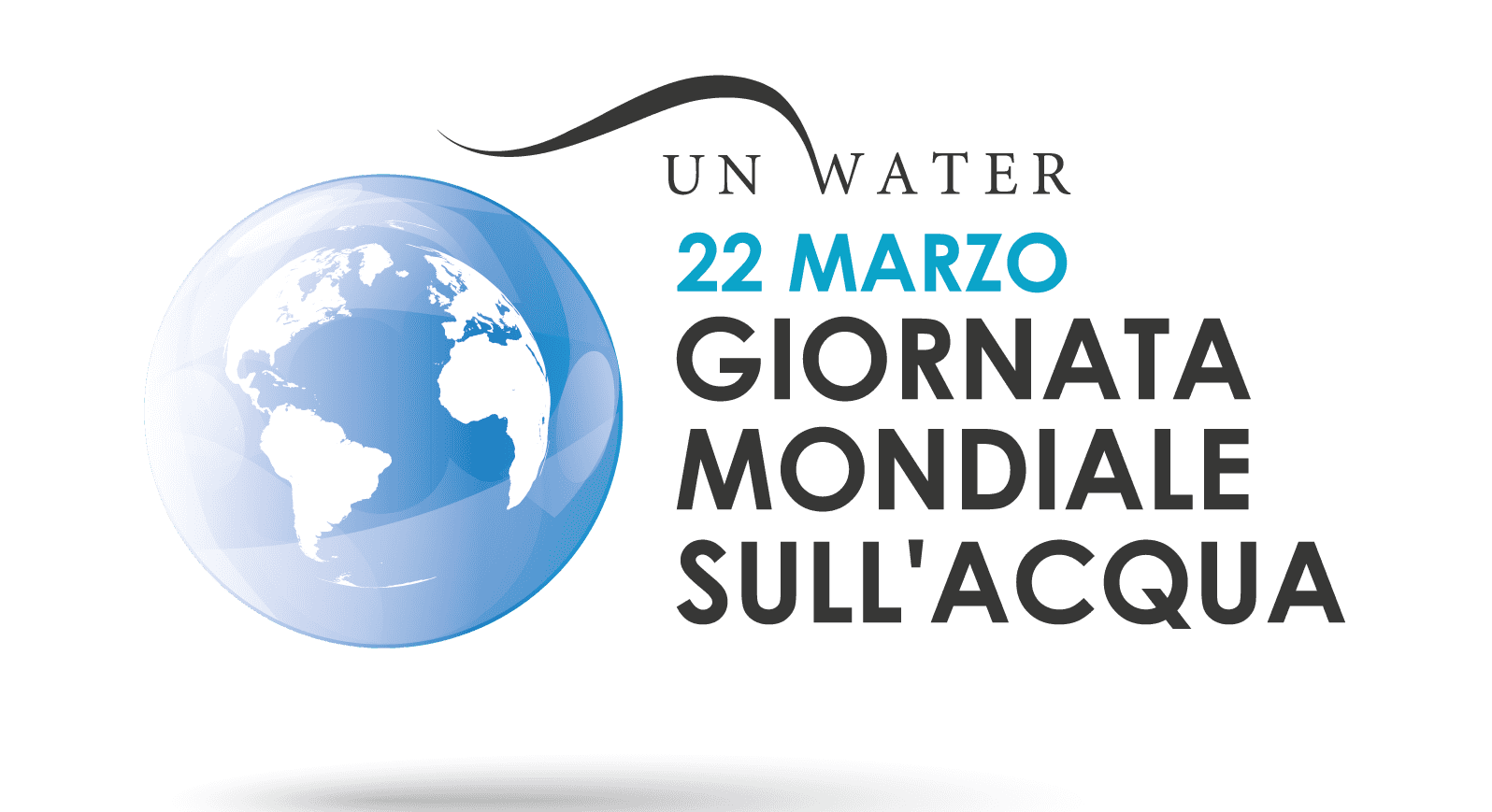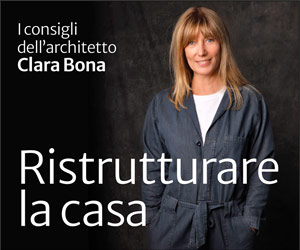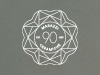Contenuti trattati
L’acqua non è solo fonte di ogni forma di vita, ma è la base della salute e dello sviluppo delle nostre società; questo è l’importante messaggio lanciato da Audrey Azoulay, Direttrice-Generale dell’UNESCO, nel 2023. Il risparmio idrico e la tutela dell’acqua sono dunque obiettivi fondamentali dell’UNESCO e delle Nazioni Unite; l’acqua garantisce cibo e benessere, ma ancora oggi oltre 2 miliardi di persone non hanno accesso all’acqua dolce potabile, quasi un terzo della popolazione mondiale. È quindi urgente agire per garantire a tutti l’accesso all’acqua. Anche il cambiamento climatico sta producendo gravi conseguenze che minacciano di peggiorare siccità e penuria d’acqua, così come portata e frequenza di piogge e alluvioni.
Stati, Enti, Associazioni, ONG, scienziati, sono uniti e concordi nella necessità di elaborare programmi atti a risolvere parte di queste problematiche e a garantire l’accesso all’acqua e la disponibilità della stessa a quante più persone possibile, oltre che la tutela di questo bene dal valore inestimabile, che permette alla natura di continuare a produrre e fornirci cibo e alla vita di ogni specie di andare avanti.
Bisogna agire in ogni ambito: dal cambiamento delle semine e delle modalità di coltivazione, alla realizzazione dei dissalatori per sfruttare le acque marine, al miglioramento delle infrastrutture come gli acquedotti italiani per evitare una dispersione di oltre il 40% della risorsa idrica. Inoltre, è certamente fondamentale porre l’accento sul riconoscimento di ogni ambito in cui l’acqua si rivela indispensabile e insostituibile per la vita degli esseri umani e dell’ambiente naturale. Solo, infatti, un approccio onnicomprensivo al problema può suggerire soluzioni adeguate per fare fronte alla crisi mondiale di questa risorsa. L’idea della valutazione non ha solo l’obiettivo di sensibilizzare i singoli, le popolazioni e i governi; la definizione soggettiva e oggettiva dell’impatto dell’acqua sulla vita di ciascuno pone le basi per una vera e propria condivisione di responsabilità tra utenti, istituzioni ed enti che, a livello globale, gestiscono gli approvvigionamenti e prendono decisioni sugli investimenti per impianti, reti, infrastrutture, depurazione, tutela degli ecosistemi.
Il bilancio idrico in Italia: troppa o troppo poca
Quanta acqua è disponibile oggi in Italia? Lo speciale report “Italy for climate” pubblicato nel 2023 da Fondazione Sviluppo Sostenibile mette in evidenza luci ed ombre sulla questione acqua nel nostro Paese, in cui emerge la dicotomia tra abbondanza e scarsità di acqua, considerata troppa o troppo poca. Il nostro rapporto con la risorsa idrica infatti è sempre più complesso e dettato dal cambiamento climatico, che provoca l’alternanza di momenti di siccità e scarsità estrema, a momenti in cui invece la disponibilità di acqua diventa troppa e concentrata in poco tempo, causando danni. Questa fase che stiamo attraversando viene chiamata di “anormalità climatica permanente“. Oggi 12 milioni di individui, pari ad un italiano su cinque, vivono in zone potenzialmente allagabili. Circa 6,9 milioni di persone, 1,1 milioni di imprese e 4,9 milioni di edifici sono minacciati da pericolosità idraulica di livello medio o elevato.
L’Ispra ha redatto il bilancio idrico nazionale, dal quale emerge che, prendendo in esame il trentennio 1991-2020, la disponibilità media della risorsa idrica in Italia è stata pari a 134 miliardi di metri cubi all’anno, attestando il nostro Paese come il terzo in Europa con la maggiore disponibilità di acqua, necessaria non solo alle attività umane, ma anche al sostentamento di tutti gli ecosistemi. Questo valore, però, ridotto già del 20% rispetto agli inizi del secolo scorso, potrebbe diminuire ancora del 40% (con picchi anche del 90% al Sud) se non ci adopereremo in modo fattivo per tagliare le emissioni di CO2. Allo stesso tempo, l’Italia ha il record europeo di prelievi di acqua, con ben 40 miliardi di metri cubi all’anno (prelevati dalle falde acquifere o dai fiumi), ciò fa sì che il Bel Paese sia anche quello con il maggior grado di stress idrico, rispetto alla reale disponibilità.
Lo stress idrico, infatti, va proprio a misurare la percentuale di acqua disponibile sul territorio che viene prelevata dall’uomo, valori maggiori del 20% indicano una situazione di stress della risorsa. Per capire la situazione del nostro Paese basti pensare che oggi le attività dell’uomo ne impiegano già il 30%; percentuale che nelle zone del Centro-Sud potrebbe raggiungere anche l’80%. (Fonte dati: World Resources Institute)
Fuori dall’Europa, i Paesi più colpiti dallo stress idrico sono in Medio Oriente e in Nord Africa, dove ne è esposta più dell’80% della popolazione e la situazione è destinata a peggiorare. Sempre dai dati del WRI (World Resources Institute) nel 2025 si aggiungerà un altro miliardo di persone a quelle che già oggi vivono in condizioni di stress idrico. La domanda globale di acqua aumenterà dal 20% al 25%.
Il consumo di acqua pro capite in Italia è il più alto d’Europa
Come utilizziamo l’acqua in Italia? Il settore più idro-esigente che quindi detiene il primato per consumo di acqua è certamente l’agricoltura, con 16 miliardi di metri cubi all’anno – ovvero il 40% del totale, ma l’Italia vanta anche il record europeo di acqua prelevata per usi civili, con ben 9 miliardi di metri cubi ogni anno (e +70% rispetto al 2000), doppiando i valori di Germania, Francia e Spagna. Questo è causato principalmente per due motivi: da un lato a causa di investimenti insufficienti nelle infrastrutture idriche che risultano molto vecchie e oggi perdono circa 42 litri per ogni 100 litri prelevati, dall’altro perché ogni cittadino italiano consuma in media 220 litri di acqua al giorno, facendoci registrare il consumo più alto d’Europa.
Per quanto riguarda le industrie, queste invece utilizzano circa 8 miliardi di metri cubi di acqua all’anno, anche se, grazie al grande lavoro che si sta facendo per l’ottimizzazione delle risorse e gli investimenti in ricerca e sviluppo per favorire sostenibilità ed economia circolare, questo valore si è quasi dimezzato nell’ultimo ventennio.
Conoscere però l’effettiva quantità di acqua prelevata dall’ambiente ogni anno non è però un’impresa semplice, in quanto la maggior parte dei prelievi, a partire dall’agricoltura fino alle attività industriali, non sono soggetti a misurazione diretta, per cui la conoscenza di questi dati risulta parziale e incerta. Tenendo comunque conto di queste irregolarità nella rilevazione dei dati, in Europa, l’Italia si conferma il Paese con i maggiori prelievi in assoluto con 40 miliardi di metri cubi/anno, seguita da Spagna, Francia e Germania.
Quanto costa l’acqua potabile in Italia?
L’Italia attualmente ha una delle tariffe più basse d’Europa per l’acqua potabile, di circa il 40% in meno, con un costo medio di un metro cubo di acqua pari a circa 2,35 euro e una bolletta media a famiglia di 448 euro. L’accesso all’acqua ad un prezzo conveniente non deve però incentivare un eccesso di consumo, motivo per cui è bene portare avanti campagne di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini a favore di un utilizzo consapevole di questa risorsa di enorme valore ma non inesauribile, in modo da promuovere approcci virtuosi e ridurne gli sprechi.
Infatti, come sottolineato da In a Bottle, quando si parla di consumo dell’acqua si è portati a pensare più al costo in bolletta, che alla quantità utilizzata pro capite e per nucleo familiare. La maggior parte dell’acqua ogni anno, equivalente circa al 39%, è utilizzata per doccia e bagno, generando così uno spreco di acqua: solo per lavarsi i denti, infatti, se non si chiude il rubinetto, si possono sprecare fino a 30 litri d’acqua al giorno. Il censimento Istat ha evidenziato che per 2 persone si consumano circa 440 litri al giorno ovvero 120 metri cubi/anno. Gran parte dell’acqua viene utilizzata per lavare i piatti, in bagno, per lavare gli abiti, per pulire casa e innaffiare.
È certamente importante tutelare le fasce più deboli e le zone che vivono in costante scarsità di acqua, sostenendo il risparmio ed un utilizzo efficiente della risorsa idrica. I cittadini devono farsi promotori di buone pratiche per evitare che l’acqua vada sprecata, dalle più semplici come: non utilizzare l’acqua potabile per lavare l’auto o irrigare piante e giardini; non lasciar scorrere l’acqua mentre ci si lava i denti, privilegiare le docce invece dei bagni; a quelle più complesse come: adottare nelle abitazioni e nei palazzi sistemi di recupero delle acque piovane o la separazione degli scarichi.
Certamente, però la responsabilità di tutto questo non ricade solo sulle scelte dei singoli cittadini, ma è quanto mai importante che le normative impongano il recupero delle “acque grigie” nelle case nuove o in ristrutturazione o il divieto di utilizzare l’acqua potabile per i sanitari, imponendo quindi l’obbligo di inserire sistemi di filtraggio che veicolino l’acqua utilizzata nei lavandini all’interno degli scarichi dei water.
L’impronta idrica di ciascuno fa la differenza
Il consumo individuale di acqua non è soltanto quello “diretto”, cioè relativo all’acqua che beviamo o utilizziamo ogni giorno per altre necessità (lavarsi, cucinare, irrigare ecc..). Maggiore, nel complesso, è la quantità impiegata per produrre gli alimenti, i vestiti che indossiamo, i beni di produzione industriale che acquistiamo. In base allo stile di vita condotto dai singoli, si può calcolare la loro impronta idrica (water footprint) che può essere più o meno elevata e avere quindi una diversa incidenza sui consumi a livello globale. Proprio come l’impronta ecologica calcola l’impatto di un individuo, una città o una nazione sull’ambiente, quella idrica indica il volume d’acqua necessario a produrre tutto ciò di cui si fa quotidianamente uso. Ogni bene di consumo ha una propria impronta, derivante dalla quantità di acqua che “assorbe” in tutta la durata del suo ciclo vitale.
Quindi, se ci serviamo di prodotti con un’impronta idrica poco sostenibile, di conseguenza aumenta anche la nostra. Fare la spesa senza questa consapevolezza contribuisce a sprecare acqua: in proporzione, molta di più di quando si lascia un rubinetto aperto. Ad esempio, più si scelgono prodotti industriali, di importazione o low-cost, più il consumo è incrementato.
In particolare, in riferimento al settore dell’abbigliamento, la coltivazione e la lavorazione del cotone, ad esempio, richiedono un’enorme quantità d’acqua. È bene sapere che per produrre una T-Shirt occorrono circa 2.500 litri d’acqua; per un paio di jeans in denim, ne vengono impiegati 10.000 litri. I dati diventano ancora più impressionanti se si pensa che questa fibra – il cotone – è impiegata anche per la realizzazione di indumenti low-cost, con un prezzo di pochi euro per l’acquirente finale. Motivo per cui sarebbe preferibile dimezzare gli sprechi anche in questo settore, favorendo il riuso e la circolarità, come nel caso del second hand, o prodotti provenienti da filiere controllate e certificate.
Quanta acqua occorre per…
- Per produrre una bottiglia da 0,75 litri di vino servono 639 litri d’acqua.
- Per 1/2 kg di carne bovina, occorrono 7.751 litri, 2.401 litri per 1/2 kg di carne suina, 3.073 litri per altrettanta carne ovina.
- Anche caffè e tè hanno un’impronta idrica poco sostenibile: per un Kg di caffè tostato, 4.738 litri d’acqua; 560 litri per una confezione di tè da 20 filtri. La produzione di una confezione da 1 Kg di riso richiede 3.440 litri.
- Compresi gli imballaggi, per un litro di latte si consumano 1.033 litri d’acqua; per un succo di frutta da 750 ml, 661 litri; per una confezione di olio d’oliva 13.353 litri.
- Vuoi conoscere l’impronta idrica della tua spesa? Prova sul sito: https://www.waterfootprint.org/resources/interactive-tools/
Come evitare gli sprechi di acqua
Alcune ricerche (fonte: In a Bottle) hanno evidenziato che gli italiani sono davvero poco attenti al consumo di acqua, 1 italiano su 3 (33%) non presta attenzione agli sprechi d’acqua in casa: a trionfare purtroppo è il “non ci faccio caso”. Il 27% degli italiani, ad esempio, lascia scorrere l’acqua mentre si lava i denti, il 33% degli uomini ammette di lasciare il rubinetto aperto mentre si rade la barba per evitare di dover fare “apri e chiudi” per pulire il rasoio. Durante l’acquisto di un elettrodomestico solo una piccola percentuale fa attenzione ai consumi idrici riportati sull’etichette. Molto probabilmente la maggior parte non sa che tenere aperto il rubinetto quando ci si lava i denti comporta uno spreco dai 6 agli 8 litri, mentre quando ci si rade, tra insaponatura e rasatura si può arrivare addirittura a 35-45 litri. Fare la doccia invece del bagno permette inoltre di risparmiare fino al 70% di acqua, ma bisogna essere molto attenti perché con una doccia gocciolante si sprecano più di 2mila litri d’acqua.
Qualche consiglio su come agire correttamente per evitare inutili sprechi di acqua? Ogni persona può contribuire anche nel quotidiano a questa nobile causa, modificando alcune abitudini. Ad esempio:
- quando ci si lava i denti è opportuno evitare di lasciare scorrere l’acqua, ma utilizzare un bicchiere;
- quando si lavano le mani è sufficiente poca pressione al rubinetto;
- installare gli aeratori nei rubinetti per diminuire il flusso;
- utilizzare la doccia invece della vasca;
- utilizzare una bacinella sia quando ci si fa la barba che quando si lavano le stoviglie;
- avviare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico evitando di utilizzare questi elettrodomestici anche quando si hanno pochi indumenti o pochi piatti da lavare (la lavatrice utilizza dai 90 ai 160 litri di acqua a ciclo);
- evitare ove possibile il prelavaggio dei capi;
- evitare di lavare le auto a casa o per strada e preferire le nuove soluzioni senza acqua o a basso impatto ambientale;
- evitare di innaffiare le piante o irrigare il giardino con acqua potabile.
Approfondisci l’argomento rubinetti e miscelatori per il risparmio idrico:
Obiettivi Agenda 2030: garantire l’accesso universale e la gestione sostenibile dell’acqua
L’obiettivo 6 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è dedicato all’acqua, sottolineando la necessità di garantire a tutti l’accesso e la gestione sostenibile dell’acqua. Viene specificato punto per punto che l’accesso all’acqua potabile deve essere universale ed equo, sicuro e alla portata di tutti (ciò che a noi sembra scontato, in molte parti del mondo è tuttora irraggiungibile!). La disponibilità idrica deve andare di pari passo con l’adeguamento dei servizi igienici, delle fognature, con la riduzione dell’inquinamento e la protezione degli ecosistemi; occorre approntare soluzioni per evitare il rilascio di sostanze chimiche e lo scarico non controllato nel sistema idrico, incrementando e migliorando il trattamento delle acque reflue.
La consapevolezza dell’impronta idrica di prodotti di consumo quotidiano è fondamentale per promuovere una scelta consapevole e sostenibile.
Acqua potabile: più controllo
La definizione di acqua potabile si riferisce a quella destinata al consumo umano, regolamentata in Italia dal Decreto Legislativo 31 del 2001, che attua la Direttiva Europea 98/83/CE. Questo decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano per proteggere la salute dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione, garantendo salubrità e pulizia. Le diverse acque disponibili in commercio rispondono ai requisiti previsti dalla norma, e le etichette sulle bottiglie forniscono informazioni chimico-fisiche e microbiologiche, tutte rientranti nei parametri di legge.
L’acqua potabile è spesso un bene dato per scontato nelle nostre case, eppure non tutti sanno che la sua qualità va controllata e manutenuta. Essa infatti viene garantita dal fornitore solo a monte delle reti di approvvigionamento domestico, mentre a valle la responsabilità è del gestore, il quale deve occuparsi fino all’ultimo punto di prelievo possibile, ovvero al contatore idrico domestico. Poiché l’acqua non è sterile – contiene minerali, microrganismi, batteri – i pericoli non mancano: ad esempio, la legionella si moltiplica nelle acque stagnanti ad alta temperatura (tra 20°C e 50°C), per poi essere inalata come aerosol sotto la doccia o dai rubinetti.
All’interno delle abitazioni, è compito dei proprietari preservare l’acqua potabile e agire in modo da non comprometterne la sicurezza, sia in ingresso sia in uscita. Le acque reflue di lavandini e elettrodomestici possono infatti rifluire dall’abitazione alla rete pubblica, inquinandola. Limitare le contaminazioni diviene necessario per la salute della famiglia e per rispettare la legislazione vigente.
Il Decreto Legislativo n. 31/2001 (Testo Unico sulle Acque), che integra la Legge Quadro sulle Acque (L. 36/1994) e fornisce ulteriori dettagli sulla gestione delle risorse idriche, comprese le procedure di concessione e l’utilizzo delle risorse idriche, e la Drinking Water Directive europea del 2020 sono oggi i principali riferimenti in tema. “È essenziale che l’impianto di acqua potabile, con tutti i raccordi, i tubi e le altre parti, non solo sia progettato, costruito e gestito secondo le norme di tecnologia generalmente accettate, ma anche regolarmente mantenuto. Questo perché difetti e malfunzionamenti, causati ad esempio dall’usura, possono mettere in pericolo la qualità dell’acqua potabile” – ha spiegato Dario Di Gregorio, tecnico di Resideo, fornitore di soluzioni per la sicurezza.
Gli accorgimenti per avere acqua potabile non sono molti. In caso di ristrutturazione dell’impianto idrico, ad esempio, conviene prevedere schemi di distribuzione in serie o ad anello con appositi raccordi che favoriscano lo scorrere del liquido, evitandone il ristagno. Speciali dispositivi disponibili in commercio possono assicurare un flusso continuo di acqua nell’impianto di adduzione, grazie a un prelievo diretto dalla rete idrica, e di conseguenza il ricambio automatico nelle zone a rischio ristagno. L’impianto dovrebbe essere svuotato regolarmente per consentire l’ingresso di nuova acqua pulita.
Inoltre, per evitare la legionella, è consigliabile mantenere l’acqua fredda sanitaria sotto i 20°C e quella calda sopra i 50°C, isolando le tubazioni e posizionandole correttamente: la linea calda deve essere posizionata superiormente alla fredda per limitare il trasferimento di calore, mentre quella fredda deve essere sempre lontana da possibili fonti di calore.
Qualità dell’acqua destinata al consumo umano
In Italia, la regolamentazione relativa alla “qualità dell’acqua destinata al consumo umano” è riportata nel Decreto Legislativo n. 31 del 2001 che recepisce la Direttiva Europea 98/83/CE, applicabile a tutte le acque utilizzate in ambito domestico e nelle imprese alimentari per la preparazione di cibi e bevande. Il Ministero della Salute ha osservato che, oltre all’uso potabile, il “consumo umano” implica il contatto dell’acqua con il corpo e quindi le varie pratiche di lavaggio o gli utilizzi per cucinare. Di conseguenza, se l’acqua del rubinetto contiene temporaneamente sostanze inquinanti, non dovrebbe essere impiegata neppure in altri modi, in quanto anche una semplice doccia potrebbe essere dannosa per la salute.
L’acqua potabile degli acquedotti viene sottoposta a severi e numerosi controlli: certificano che è sicura e sana e che contiene la quantità di sali minerali giusta per l’organismo.
Normativa di riferimento: come essere certi che tutto sia in regola
Le tabelle allegate al Decreto 31/2001 contengono una serie di parametri microbiologici (relativi alla presenza di batteri come escherichia coli ed enterococchi) e chimici (tra cui arsenico, floruri e cromo), i cui valori sono costantemente monitorati dalle aziende che gestiscono il servizio idrico nei vari Comuni e dalle Asl del territorio.
In determinati casi, i parametri presenti nella Direttiva Europea 98/83/CE sono stati riproposti nella tabella italiana in modo più restrittivo; come per esempio i trialometani, il cui valore di 100 microgrammi/litro è stato ridotto a 30 microgrammi/litro. Può capitare, inoltre, che le acque siano contaminate da altre sostanze non incluse nella tabella e quindi non soggette ai controlli ordinari. A questo proposito il Decreto 31/2001 stabilisce che “le acque destinate al consumo umano non devono contenere microrganismi o parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana”.
A questo proposito è specificato che la Asl assicura “una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di parametro, qualora vi sia motivo di sospettarne la presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. La fissazione di valori per parametri aggiuntivi è di competenza dello Stato”. In linea generale, i valori parametrici individuati nelle tabelle si fondano sugli orientamenti stabiliti dall’Organizzazione mondiale della Sanità (www.who.int), mentre la valutazione del rischio sulle sostanze non espressamente indicate dal Decreto 31/2001 è effettuata dall’Istituto Superiore di Sanità (www.iss.it.)
Negli anni, il quadro normativo si è ampliato con il decreto ministeriale n. 174 del 2004 e il decreto legislativo n. 28 del 2016, che stabilisce i requisiti per la tutela della salute dalla presenza di sostanze radioattive.
Situazioni soggette a controlli e monitoraggio continuo
Nonostante il monitoraggio costante, casi di contaminazione possono rendere temporaneamente non potabile l’acqua domestica. Ordinanze dei sindaci in risposta a eventi meteorologici o valori alterati di sostanze nocive sono all’ordine del giorno. La popolazione è quindi chiamata a prestare sempre attenzione a tali avvisi e a fidarsi dei sistemi di controllo e prevenzione implementati dalle autorità competenti.
Analizzare l’acqua di rubinetto
Per analizzare l’acqua del rubinetto, esistono laboratori accreditati, kit fai-da-te online o in farmacia con costi che vanno dai 50 ai 200 euro, in base ai parametri analizzati. Un controllo periodico, considerati i costi contenuti, può essere utile per valutare l’intervento sull’impianto, ad esempio con un addolcitore per acque molto dure. Tuttavia, è importante ricordare che l’acqua erogata fino al punto di innesto alle tubature condominiali è garantita dal fornitore, controllato dalle ATS locali.
Inoltre, per avere maggiori rassicurazioni circa la bontà della propria acqua di rubinetto è sempre possibile verificare le normative locali sulla qualità dell’acqua e assicurarsi che rispetti gli standard stabiliti. Queste informazioni sono generalmente disponibili presso le autorità locali o fornitori di servizi idrici.
Arsenico nell’acqua: concentrazioni massime consentite
Fra le sostanze più pericolose che alterano l’acqua potabile figura l’arsenico, un metalloide presente in natura sia in forma organica che inorganica, legato a manifestazioni geotermiche e in parte proveniente dall’alterazione di rocce vulcaniche. Questo elemento chimico è in grado di contaminare le falde acquifere sotterranee e una volta ingerito, soprattutto se in concentrazioni massicce, può causare gravi disturbi all’essere umano. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) si è occupata per la prima volta del problema nel 1980, stabilendo un limite massimo di concentrazione pari a 50 microgrammi/litro. Un valore che l’attuale Direttiva Comunitaria 98/83/CE ha ridotto a 10 microgrammi/litro. Per anni l’Italia ha chiesto e ottenuto deroghe (20 microgrammi/litro), che di fatto hanno consentito il consumo di acqua potabile contaminata.
Nel 2013, dopo numerosi pareri medici attestanti la pericolosità dell’arsenico, la tolleranza è terminata e oggi superare la concentrazione di 10 microgrammi/litro è considerato fuorilegge.
Altre sostanze potenzialmente a rischio
Se l’arsenico, i floruri e altri elementi come il cromo e il benzene compaiono nella tabella delle sostanze da monitorare, ve ne sono alcune a rischio, non presenti nell’elenco e che quindi possono sfuggire ai controlli. È il caso dei PFAS – le sostanze perfluoro alchiliche – che possono inquinare le acque sotterranee e quelle superficiali. Nel 2013 una ricerca sperimentale promossa dal Cnr e dal Ministero dell’Ambiente su potenziali inquinanti nel bacino del Po e nei principali bacini fluviali italiani, portò alla scoperta di queste sostanze. Erano utilizzate a partire dagli anni ’50 in ambito industriale per rendere resistenti ai grassi e all’acqua tessuti, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti ma anche per la produzione di pellicole fotografiche, schiume antincendio e detergenti per la casa.
Il Dottor Stefano Polesello, ricercatore dell’Irsa (www.irsa.cnr.it) specializzato in inquinamento ambientale e coordinatore dello studio di valutazione del rischio ambientale e sanitario associato proprio alla contaminazione da Pfas, ha spiegato che solitamente l’acqua delle falde sotterranee è di buona qualità perché in profondità c’è un filtraggio naturale del terreno.
Nella Pianura Padana l’acqua è una delle migliori d’Italia e l’unico, vero rischio è l’inquinamento della falda, come purtroppo è accaduto in Veneto. A partire dagli anni ’70, una fabbrica ha scaricato sostanze tossiche non degradabili contaminando l’acqua, che per oltre 40 anni è stata bevuta dai cittadini ignari. Il caso Veneto fa capire come sia necessario conoscere il territorio, non solo dal punto di vista geologico. È necessario quindi individuare l’eventuale presenza di impianti industriali e in prossimità di questi compiere analisi ad hoc.
Presenza di calcare nell’acqua: benefici o rischi?
In alcune aree del Paese, l’acqua presenta valori di carbonato di calcio, noto come calcare, superiori alla media, classificate come “acque dure”. In passato si pensava che bere acqua calcarea potesse danneggiare i reni, ma si trattava perlopiù di credenze popolari non suffragate da alcun parere medico. L’assunzione di calcare, al contrario, sembra portare alcuni benefici al sistema cardiovascolare e a quello digerente.
Nonostante opinioni discordanti sulla bontà di queste acque, l’OMS ha scelto di non fissare valori guida. Il Ministero della Salute ha sottolineato che una durezza di 10-15 °F rappresenta un contenuto raccomandabile a livello sanitario. Non è possibile affermare che una durezza inferiore al limite consigliato di 10 °F sia dannosa, soprattutto con il trattamento dell’acqua.
“Per il parametro durezza – ha osservato il Ministero – viene indicato un range di valori consigliati e pertanto il mancato rispetto di questi non rappresenta una vera e propria non conformità e dovrà, di volta in volta, essere valutato ai fini dell’emanazione del suddetto giudizio di idoneità (…) Nell’equilibrio delle concentrazioni indicate, la composizione in sali minerali che conducono a una durezza di 10 – 15 °F rappresenta il miglior contenuto raccomandabile a livello sanitario. Ciò nonostante, non è possibile affermare che una durezza inferiore al limite consigliato di 10 °F sia dannosa alla salute soprattutto se, dopo il trattamento dell’acqua, con un’apparecchiatura conforme al DM 25/2012, viene data opportuna informazione all’utente”.
Calcio nell’acqua: benefico o dannoso?
La presenza di calcio nell’acqua, regolamentata dal Decreto Lgs 31/2001, può essere benefica o dannosa a seconda delle dosi e dei fattori personali. L’accumulo di calcare può danneggiare tubature ed elettrodomestici, motivando quindi l’uso di depuratori.
Tubature condominiali: monitorare le perdite per garantire qualità
Nonostante la qualità dell’acqua erogata dal gestore sia di alto livello, il consumatore potrebbe percepire un sapore sgradevole. Le tubature condominiali, se datate, possono infatti rilasciare metalli nell’acqua, evidenziando l’importanza di sostituire o aggiornare tali infrastrutture. La presenza di perdite potrebbe anche favorire la proliferazione di batteri dannosi.
In caso di persistenza del problema, è consigliabile contattare il gestore e, se necessario, richiedere un controllo al rubinetto. È bene ricordare che il gestore è responsabile dell’acqua erogata fino al punto di consegna, ossia quello di allaccio al condominio. Da lì in poi, fino ai rubinetti dei singoli appartamenti, il responsabile diventa l’amministratore, che ha il compito di vigilare sulle parti comuni dell’edificio e mantenerle in buono stato. Non esiste, però, una norma che obblighi l’amministratore a eseguire controlli periodici e in molti casi occorre che la verifica sia proposta dal proprietario durante l’assemblea di condominio. Nel caso in cui l’amministratore ignori le richieste dei condòmini e non predisponga alcun controllo, il professionista può essere soggetto a sanzioni.
Quando la rete idrica attinge dal fiume
Gli esempi di Torino e Firenze
Passeggiando fra le bellezze di Firenze e Torino è facile imbattersi in uno dei tanti ponti che solcano i celebri corsi d’acqua cittadini, l’Arno e il Po. È incredibile pensare che parte dell’acqua che scorre nei due fiumi, tutt’altro che limpida e pulita in prossimità del centro città, è la stessa che esce dai rubinetti delle case dei fiorentini e dei torinesi; serve per tutti gli usi domestici e viene anche normalmente bevuta.
Nel capoluogo toscano, un approvvigionamento idrico sicuro è fornito dall’impianto di potabilizzazione dell’Anconella, che attraverso elaborati processi di filtraggio e disinfezione rende consumabile l’acqua dell’Arno.
Lo stesso avviene a Torino dove, dalla fine degli anni ’50, un impianto simile preleva l’acqua del Po e la trasforma in potabile, alimentando circa un quarto della rete idrica cittadina.
Sulle piccole isole
Poter disporre di acqua potabile in molte isole minori, specie in quelle a vocazione turistica è da sempre un problema di non facile soluzione. A Capri, per esempio, in assenza di sorgenti sul posto, il rifornimento idrico è garantito – dal 1977 – tramite condotte sottomarine collegate alla penisola sorrentina. Sempre nell’isola campana, sono attive le “case dell’acqua”, strutture che la erogano, naturale o gasata, a pochi centesimi al litro. La raccolta nelle cisterne approvvigiona d’acqua non potabile, per altri utilizzi.
All’Isola d’Elba i rifornimenti arrivano tramite l’acquedotto elbano dalla Val di Cornia fin dal 1988, per mezzo di una struttura sottomarina. La condotta è però sottoposta a sollecitazioni, sia dal terreno sia dalle navi che attraversano il canale di Piombino ed è soggetta al deperimento del materiale con cui è stata costruita. Negli anni il consumo idrico sull’isola è cresciuto in maniera esponenziale, mentre le riserve del continente, dalle quali l’Elba dipende, si sono ridotte a causa della siccità. Per questi motivi e per rendere autonoma l’isola, è stato avviato il progetto che prevede la costruzione di un dissalatore capace di rendere bevibile l’acqua marina.
Impianti di desalinizzazione
A Lipari, nelle Eolie, un impianto desalinizza l’acqua del Tirreno per garantire l’erogazione potabile soprattutto nei mesi estivi, quando le piogge sono ridotte e la popolazione raddoppia. Il desalinizzatore, che si basa sul principio di osmosi inversa e sfrutta l’energia di un impianto fotovoltaico, è stato progettato per sostituire i serbatoi di accumulo del passato. Altri rifornimenti vengono trasportati dalle navi cisterna, poi immessi nelle vasche comunali. A Ustica vi è un dissalatore dal 2001, che in origine rendeva potabile l’acqua marina attraverso un processo di distillazione: il liquido veniva fatto evaporare e poi ricondensato, privo della componente salina, tramite refrigerazione. Un procedimento complesso, ma soprattutto energivoro, tanto da richiedere l’utilizzo di una centrale termoelettrica dedicata. Così, a partire dal 2015, si è scelto di utilizzare filtri a membrana, attraverso i quali l’acqua subisce diversi gradi di depurazione e, una volta dissalata, viene resa potabile con l’aggiunta di oligoelementi.
Quanta acqua in bottiglia consumano gli italiani?
Gli italiani sono i più grandi consumatori di acqua minerale in bottiglia, con ben 223 litri pro capite (contro la media europea di 118 litri), questo quanto rilevato dal The European House, che ha pubblicato il libro “Valore acqua per l’Italia 2022“.
L’acqua del rubinetto in Italia è tra le migliori d’Europa: controllata, sicura e con un gusto il più delle volte gradevole. Ma nonostante l’attestato di qualità, certificato dall’Irsa (Istituto di ricerca sulle acque del Cnr), gli italiani prediligono il consumo di minerale in bottiglia. Un dato eloquente che dimostra come in tanti non si fidino ancora della rete idrica cittadina, nonostante gli sforzi delle amministrazioni locali che da anni pubblicizzano il consumo domestico. Significativo il caso di Torino, dove la Smat (Società Metropolitana Acque di Torino), l’ente che gestisce il servizio, può addirittura vantarsi di rifornire di acqua potabile gli astronauti italiani, russi e americani nelle missioni spaziali.
A disincentivare il consumo dell’acqua di rubinetto contribuiscono senza dubbio le notizie di cronaca su casi circoscritti di acqua inquinata o contaminata da sostanze nocive e dannose per l’uomo, che costringono i sindaci a emettere ordinanze urgenti che vietano, per periodi di tempo più o meno lunghi, l’utilizzo domestico d’acqua per scopi alimentari. Altre volte, a renderla non bevibile, sono gli eventi naturali: il maltempo, per esempio, può intorbidire l’acqua degli invasi e il conseguente calo di pressione in rete causa l’interruzione dell’erogazione. Criticità a parte, proprio grazie all’attenzione dell’opinione pubblica e al costante monitoraggio degli Enti predisposti ai controlli, oggi l’acqua del rubinetto è sicura e molto economica. Due buone ragioni per sceglierla, con le debite accortezze rispetto a quanto accade nella propria area di residenza.
La Direttiva sull’Acqua Potabile mira proprio a ridurre l’uso di bottiglie d’acqua, promuovendo la fiducia nell’acqua di rubinetto. Ciò dovrebbe generare un risparmio di oltre 600 milioni di euro all’anno per le famiglie e ridurre i rifiuti di plastica del 17%, con impatti positivi sull’ambiente e sulle emissioni di gas serra. Gli Stati membri sono infatti spinti a promuovere l’acqua di rubinetto, aumentando di conseguenza la trasparenza sui controlli e sulla sicurezza, rafforzando la fiducia dei cittadini verso i servizi idrici.
La Direttiva promuove, inoltre, l’accesso all’acqua potabile per tutti, incentivando la presenza di distributori d’acqua in spazi pubblici e incoraggiando ristoranti e servizi di ristorazione a offrire acqua potabile gratuita o a prezzi modici.
Si conoscono gli effetti della plastica? 9 italiani su 10 ne sono al corrente
Nonostante il quotidiano utilizzo, gli italiani si rivelano consapevoli dei rischi ambientali causati dall’utilizzo della plastica. Più del 90% si è dichiarato informato sul fatto che nel 2050 nei nostri mari ci sarà più plastica che pesci, che il trasporto di bottiglie di plastica comporta un elevato impatto ambientale in termini di emissioni di anidride carbonica e che l’acqua minerale in bottiglia ha un costo elevato variabile dai 300 ai 700 euro a famiglia, a seconda della qualità del prodotto. (Fonte: Lifegate)
Per poter rinunciare alle bottiglie di plastica e passare a bere l’acqua di rubinetto, gli italiani chiedono però maggiori garanzie sui controlli, la qualità e la sicurezza. Per rispondere all’esigenza di sicurezza e incentivare il consumo di acqua potabile del rubinetto, la Commissione Europea ha infatti revisionato la Direttiva 98/83/CE sulle acque potabili.
Presenza di microplastiche nell’acqua da bere, facciamo chiarezza
- ci sono quelle primarie, realizzate di proposito in dimensioni ridotte per essere usate – ad esempio – nei cosmetici (trucchi, detergenti, dentifrici), nelle vernici, nelle paste abrasive e nei fertilizzanti, per le loro proprietà esfolianti e leviganti;
- mentre, quelle secondarie (la stragrande maggioranza rilevata negli oceani) sono originate dall’usura, dal deterioramento e dalla frammentazione di materiali in plastica di dimensioni maggiori, come bottiglie, buste di plastica, tessuti sintetici o copertoni delle ruote.
L’acqua in bottiglia è di migliore qualità: è vero?
Differenze tra acqua del rubinetto, imbottigliata e trattata dai depuratori
Sono tutte acque potabili e quindi destinate al consumo umano. L’acqua del rubinetto può provenire da diverse fonti (falde sotterranee, fiumi, laghi, …) ma viene sempre analizzata, eventualmente purificata e disinfettata, prima di essere erogata nella rete idrica. L’acqua imbottigliata proviene generalmente da sorgenti di montagna (di solito molto pure), ma ci possono essere anche acque imbottigliate provenienti da altre fonti. Anche queste sono attentamente analizzate ed eventualmente (in casi più rari) purificate, prima dell’imbottigliamento. I depuratori commerciali (quelli più semplici) sono invece dispositivi che purificano ulteriormente l’acqua, già di per sé potabile (di rubinetto), che per qualche ragione deve/vuole essere ulteriormente purificata o per cui si vogliono cambiare e migliorare certe caratteristiche come quelle organolettiche (odore, sapore) o chimiche (scambio di ioni, come lo ione calcio scambiato con lo ione magnesio… ).
La possibile ragione della necessità di un’ulteriore purificazione è legata al fatto che l’acqua potabile del rubinetto viene garantita dal fornitore con una determinata qualità fino al punto di allacciamento (innesto) della rete idrica su strada. In condomini o abitazioni in cui non vengono controllate le tubature potrebbero esserci dei problemi di contaminazioni (metalli pesanti a causa di tubature vecchie, microorganismi, …) nell’ultimo tratto dalla strada al rubinetto di casa (il cosiddetto “ultimo miglio”). In questi casi la depurazione può ovviare al problema.
Serve il depuratore dove l’acqua potabile è ritenuta buona da bere?
Si sente dire sempre, per esempio, che l’acqua del rubinetto è buona da bere, ma diverse società che producono depuratori vanno nelle case su appuntamento, fanno una piccola indagine casalinga e “dimostrano” che nell’acqua ci sono sostanze pericolose per poi proporre un depuratore. Come distinguere dunque il vero dal falso?
In un’acqua potabile ci sono (e devono esserci) diverse sostanze. Non potremmo assolutamente bere un’acqua completamente pura ed esente da ogni altra sostanza. Tali sostanze sono facilmente visibili attraverso reazioni chimiche opportune. Ad esempio, si potrebbero far precipitare il calcare o i cloruri che potrebbero apparire come una sospensione/precipitato biancastro. Questo però non vuol dire che nell’acqua ci siano sostanze pericolose. Ecco perché è sempre consigliabile affidarsi a laboratori accreditati (come quelli delle Università e dei Centri di Ricerca), per avere il quadro completo sulla qualità della propria acqua, per poi fare una scelta più consapevole e, se lo si ritiene necessario, acquistare anche un depuratore. Certo è che un’acqua del rubinetto, assolutamente bevibile, può non avere un buon sapore e in questi casi un sistema di filtrazione risolve il problema.
Il depuratore impoverisce l’acqua?
Alcuni depuratori offrono acqua arricchita con ioni – ionizzata – (che sarebbe la più simile ad acqua di fonte) oppure ozonizzata… Sono “bufale” oppure no? Un buon depuratore, utilizzato e manutenuto in maniera corretta, è in grado di migliorare la qualità dell’acqua rendendola di sapore ed odore più gradevoli, in alcuni casi togliendo le ultime tracce di disinfettante a base di cloro, essenziale per la salubrità dell’acqua, ma che può risultare fastidioso, eliminando tracce di metalli pesanti o altre sostanze nocive che possono provenire dal sopracitato “ultimo miglio”, scambiando alcuni ioni con altri per migliorare la qualità finale (ad esempio, spesso il calcio viene scambiato col magnesio). Tutto questo viene fatto senza assolutamente impoverire l’acqua dalle altre sostanze che devono esserci. Bisogna quindi affidarsi, come sempre, ad aziende serie e certificate, che diano garanzie fornite da enti super partes. Qualche anno fa, il Decreto 25/2012, ha regolato anche questo ambito, e adesso le aziende produttrici di depuratori casalinghi devono rispettare tale regolamentazione.
Gli ultimi depuratori d’acqua immessi in commercio funzionano per osmosi inversa (processo utilizzato per rimuovere impurità dall’acqua dell’ultimo miglio, inclusi batteri, microplastiche e PFAS), e consentono di avere, direttamente dal rubinetto di casa, acqua leggera e priva di elementi indesiderati.