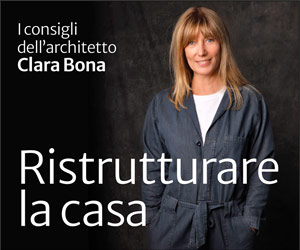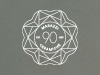Mostra MUNCH. La rivoluzione espressionista - Venezia

A cura di Manuela Vaccarone
Pubblicato il
Aggiornato il
AVVERTENZA: la Redazione non assume alcuna responsabilità, e pertanto non potrà essere ritenuta responsabile, per eventuali errori di indicazione delle date dei vari eventi che sono da considerare puramente indicative. Invitiamo i lettori a verificare l’esattezza delle date e degli orari di svolgimento delle varie manifestazioni, contattando preventivamente gli organizzatori ai numeri di telefono corrispondenti o visitando il sito web corrispondente.
Per segnalare una mostra scrivere a eventi@cosedicasa.com
Per segnalare una mostra scrivere a eventi@cosedicasa.com
-
Venezia
La mostra dedicata a Edvard Munch intende raccontare l’uomo del suo tempo, che vive e lascia un segno nella società.
Introspettivo certo, ma anche partecipativo; solo, nella sua inquietudine, ma non isolato; tanti i suoi legami con autori, artisti, letterati contemporanei – Ibsen fra tutti, di cui illustra le opere teatrali - che concorrono alla formazione del suo pensiero, alla sua rivoluzione grafica e iconografica, la sua vita.
Munch è specchio della cultura mitteleuropea e cittadino del mondo.
Munch è il suo tempo, ed è il nostro. Perché quell’urlo espressionista che nasce dal corpo e rende l’arte totalizzante, carica di dolore, memoria, denuncia, non si è mai esaurito.
Le sette sezioni della mostra, partono da Edvard Munch (Loten, 1863 - Oslo, 1944), al confronto con i fermenti naturalisti, impressionisti e con il connazionale, meno noto, Aksel Waldemar Johannessen (Kongsvinger, 1880 -Oslo, 1922): una vicenda artistica intensa e breve, con Munch condivide la ricerca di mondo interiore tormentato, ma affronta la realtà con un realismo sociale che si carica di tensione espressiva, distante dall’estetica francese che domina l’arte norvegese del tempo.
Due i capitoli sulle Secessioni, le rotture artistiche dell'area tedesca che partono da Monaco nel 1892 e che proseguono poi con Vienna, nel 1897 e Berlino, nel 1898.
L’eredità di Munch, con il suo segno vibrante e la tensione psicologica, permea questo clima, dei laboratori fertili, dove Simbolismo, Jugendstil e Postimpressionismo si intrecciarono in uno spirito di profondo rinnovamento.
Superando le premesse impressioniste, Munch guarda al Simbolismo, all’opera di Redon, Sérusier, Bonnard, alla produzione di Klinger e ai dipinti di Böcklin che lo avvicinano a un linguaggio simbolista, permeato di immagini allusive e visionarie, di sogni, interiorità e mistero.
In Belgio, la corrente assume importanza grazie ad autori come Félicien Rops - legato agli ambienti letterari decadenti parigini e influenzato da Baudelaire, Mallarmé e Verlaine - e James Ensor, inventore di un mondo grottesco popolato da maschere, scheletri e figure mostruose, sviluppando un simbolismo fantastico e a tratti caricaturale, ricco di satira sociale.
E ancora, il confronto con il Simbolismo in Italia che assume declinazioni diverse e originali, tra le sculture intense e drammatiche di Adolfo Wildt, gli scenari cupi e opprimenti di Cesare Laurenti, lo spirito ribelle di Ugo Valeri.
L’ampia rappresentazione di opere grafiche in mostra racconta il debito dell’Espressionismo tedesco al segno di Edvard Munch, la cui influenza, soprattutto nella grafica, è fondamentale per il gruppo Die Brücke.
Ne L’urlo contemporaneo riverbera la lezione di Munch e le ricadute nella sensibilità degli autori del Novecento.
La mostra è a cura di Elisabetta Barisoni.
Introspettivo certo, ma anche partecipativo; solo, nella sua inquietudine, ma non isolato; tanti i suoi legami con autori, artisti, letterati contemporanei – Ibsen fra tutti, di cui illustra le opere teatrali - che concorrono alla formazione del suo pensiero, alla sua rivoluzione grafica e iconografica, la sua vita.
Munch è specchio della cultura mitteleuropea e cittadino del mondo.
Munch è il suo tempo, ed è il nostro. Perché quell’urlo espressionista che nasce dal corpo e rende l’arte totalizzante, carica di dolore, memoria, denuncia, non si è mai esaurito.
Le sette sezioni della mostra, partono da Edvard Munch (Loten, 1863 - Oslo, 1944), al confronto con i fermenti naturalisti, impressionisti e con il connazionale, meno noto, Aksel Waldemar Johannessen (Kongsvinger, 1880 -Oslo, 1922): una vicenda artistica intensa e breve, con Munch condivide la ricerca di mondo interiore tormentato, ma affronta la realtà con un realismo sociale che si carica di tensione espressiva, distante dall’estetica francese che domina l’arte norvegese del tempo.
Due i capitoli sulle Secessioni, le rotture artistiche dell'area tedesca che partono da Monaco nel 1892 e che proseguono poi con Vienna, nel 1897 e Berlino, nel 1898.
L’eredità di Munch, con il suo segno vibrante e la tensione psicologica, permea questo clima, dei laboratori fertili, dove Simbolismo, Jugendstil e Postimpressionismo si intrecciarono in uno spirito di profondo rinnovamento.
Superando le premesse impressioniste, Munch guarda al Simbolismo, all’opera di Redon, Sérusier, Bonnard, alla produzione di Klinger e ai dipinti di Böcklin che lo avvicinano a un linguaggio simbolista, permeato di immagini allusive e visionarie, di sogni, interiorità e mistero.
In Belgio, la corrente assume importanza grazie ad autori come Félicien Rops - legato agli ambienti letterari decadenti parigini e influenzato da Baudelaire, Mallarmé e Verlaine - e James Ensor, inventore di un mondo grottesco popolato da maschere, scheletri e figure mostruose, sviluppando un simbolismo fantastico e a tratti caricaturale, ricco di satira sociale.
E ancora, il confronto con il Simbolismo in Italia che assume declinazioni diverse e originali, tra le sculture intense e drammatiche di Adolfo Wildt, gli scenari cupi e opprimenti di Cesare Laurenti, lo spirito ribelle di Ugo Valeri.
L’ampia rappresentazione di opere grafiche in mostra racconta il debito dell’Espressionismo tedesco al segno di Edvard Munch, la cui influenza, soprattutto nella grafica, è fondamentale per il gruppo Die Brücke.
Ne L’urlo contemporaneo riverbera la lezione di Munch e le ricadute nella sensibilità degli autori del Novecento.
La mostra è a cura di Elisabetta Barisoni.
Regione: Veneto
Luogo: Centro Culturale Candiani, Sale espositive II piano, piazzale Luigi Candiani 7
Telefono: 041/274 6111
Orari di apertura: 10-19. Lunedì chiuso
Costo: Ingresso libero previa registrazione al: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY3xHFeZjDZLZ7xCR_QRBdSq93z4waWqcVP8W5SPfbiNjoKQ/viewform
Dove acquistare: ingresso libero
Sito web: www.centroculturalecandiani.it
Organizzatore: Fondazione Musei Civici per il Centro Culturale Candiani