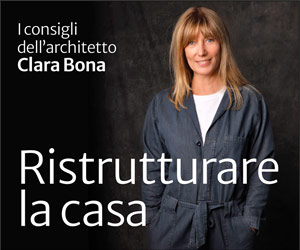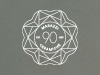- Fioritura
- Commestibilità
- Riproduzione
- Semi
- Informazioni e curiosità
- Coltivazione
- Collocazione
- Concimazione
- Esposizione e luce
- Annaffiatura
- Potatura
- Rinvaso e trapianto
- Ubicazione stagionale
- Raccolta
- Malattia e cure

- In qualità di rampicante, la pianta della vite ha bisogno di supporti cui aggrapparsi durante la crescita.
- La pianta della vite ha bisogno di pieno sole e clima temperato per produrre i suoi gustosi grappoli.
- La raccolta dell’uva si effettua da fine estate fino a novembre, a seconda della tipologia di vite.
- A seconda della destinazione d’uso e delle caratteristiche degli acini, l’uva si divide in uva da vino o da tavola.
- La pianta della vite entra in riposo vegetativo durante i mesi freddi.
La pianta della vite, scientificamente nota come Vitis vinifera, è una delle colture più antiche e affascinanti del mondo, diffusa in tutti i continenti ad eccezione dell’Antartide. Non è un albero, ma un arbusto rampicante o liana, con una struttura e un ciclo vitale molto particolari.
Per semplicità descrittiva, si può suddividere in due parti principali: una sotterranea (l’apparato radicale) e una aerea (il fusto e la chioma).
Apparato radicale
Le radici hanno due funzioni fondamentali.
- Ancoraggio: fissano saldamente la pianta della vite al terreno
- Assorbimento: assorbono acqua e sali minerali dal suolo, elementi vitali per la crescita e la produzione di frutti. L’apparato radicale è molto esteso e può scendere a diversi metri di profondità, esplorando un grande volume di terreno alla ricerca di risorse
Parte aerea
È tutto ciò che si trova sopra il terreno e che viene modellato dalla potatura dell’uomo.
- Ceppo o fusto: è legnoso, spesso nodoso e contorto nelle piante più vecchie, e funge da struttura portante
- Cordoni o bracci: sono le ramificazioni principali e permanenti che si dipartono dal ceppo. A seconda del sistema di allevamento, possono essere uno o più, disposti in orizzontale o in verticale
- Capi a frutto o tralci: sono i rami di un anno che crescono sui cordoni. È su questi tralci che si svilupperanno i germogli che porteranno i grappoli. Vengono rinnovati ogni anno con la potatura invernale
- Germogli: sono la nuova vegetazione verde che spunta in primavera dalle gemme presenti sui tralci. Su di essi si formano le foglie, i viticci e le infiorescenze (futuri grappoli)
- Gemme: sono “l’embrione” dei futuri germogli e si distinguono in: gemme ibernanti (si formano durante l’estate e si apriranno solo nella primavera successiva, dando origine alla produzione dell’anno) e gemme pronte (si sviluppano nella stessa stagione in cui si formano, dando origine a germogli secondari detti “femminelle”).
- Foglie: hanno una forma caratteristica, palmata e lobata (generalmente con 3 o 5 lobi). Sono il motore della pianta: attraverso la fotosintesi clorofilliana, utilizzano la luce solare per trasformare anidride carbonica e acqua in zuccheri, nutrimento essenziale per la pianta e per la maturazione dell’uva. Il loro stato di salute è un indicatore importante per il viticoltore
- Viticci: sono organi filiformi e flessibili, simili a delle “molle”, che la vite usa per aggrapparsi a qualsiasi sostegno trovi (pali, fili, altre piante). Sono in realtà infiorescenze modificate e dimostrano la natura rampicante della pianta
- Grappolo: è l’infruttescenza della vite, l’obiettivo finale della viticoltura. È composto da raspo o rachide (la struttura legnosa che tiene insieme tutti gli acini) e acini o bacche (i singoli frutti, cioè l’uva)
Caratteristiche generali e ciclo vitale
Come già anticipato, la vite non si autosostiene, ma necessita di sistemi di allevamento (tutori, fili, pali) per essere guidata e sorretta.
È anche una pianta molto longeva: può vivere per decenni e, in alcuni casi, superare il secolo di vita, diventando un vero e proprio monumento naturale.
La vite segue un ciclo ben preciso che si ripete ogni anno:
- Pianto (marzo): al risveglio primaverile, dai tagli della potatura fuoriesce linfa. È il segno che la pianta sta tornando attiva
- Germogliamento (aprile): le gemme si aprono e spuntano i primi germogli
- Fioritura e allegagione (maggio-giugno): compaiono i piccoli fiori, che dopo l’impollinazione si trasformano in minuscoli frutti (allegagione)
- Invaiatura (luglio-agosto): gli acini iniziano a cambiare colore, passando dal verde al giallo (uve bianche) o al rosso/viola (uve nere). Iniziano ad accumulare zuccheri
- Maturazione (agosto-ottobre): gli acini si ingrossano, accumulano zuccheri, aromi e polifenoli, mentre diminuisce l’acidità. È il periodo che porta alla vendemmia
- Riposo vegetativo (novembre-febbraio): dopo la vendemmia, le foglie cambiano colore e cadono. La pianta entra in dormienza per superare il freddo invernale
Durante le diverse fasi del suo ciclo vitale, le cure che richiede variano notevolmente (soprattutto a livello di annaffiature e concimazioni). In generale, predilige temperature miti e un’abbondante esposizione solare, pur resistendo a freddi non eccessivi. Una ventilazione moderata è benefica, poiché favorisce l’arieggiamento della pianta e riduce il rischio di patologie fungine; il calore è un altro elemento cruciale per il completamento del ciclo vegetativo.
Pur essendo adattabile a diverse tipologie di terreno, è fondamentale che il suolo non sia soggetto a ristagni idrici e che il pH non sia né troppo acido né troppo alcalino. Terreni drenati e collinosi sono i più favorevoli per lo sviluppo della vite, sebbene possano determinare una minore disponibilità idrica.
Da questi accenni preliminari sulle cure della vite, ci si rende già conto che la coltivazione di questa pianta così complessa non si può di certo improvvisare: la viticoltura è, infatti, una disciplina che richiede una profonda comprensione della sua fisiologia e delle sue interazioni ambientali.
Fioritura
La fioritura della pianta della vite avviene in primavera, generalmente tra fine maggio e inizio giugno.
Questo periodo è molto importante e delicato, poiché il successo di questa fase influenzerà direttamente la quantità e la qualità della futura vendemmia. La fioritura non è molto vistosa, ma è fondamentale per l’impollinazione e la successiva formazione degli acini d’uva.
È importante notare che il momento esatto della fioritura può variare a seconda di diversi fattori, tra cui:
- L’andamento climatico: temperature, umidità e piogge possono anticipare o ritardare l’evento
- La varietà di vitigno
- L’esposizione del vigneto
Commestibilità
Riproduzione
La pianta della vite si può riprodurre in diversi modi, ma nel mondo della viticoltura professionale si utilizzano quasi esclusivamente metodi di riproduzione agamica (o vegetativa) per garantire che le nuove piante siano geneticamente identiche alla pianta madre.
I principali metodi sono:
Per innesto (il più comune)
L’innesto consiste nell’unire due parti di diverse piante:
- Portainnesto: è la parte inferiore della pianta (il sistema radicale) e proviene da una vite americana
- Marza (o nesto): è la parte superiore (il tralcio che produce i frutti) e proviene da una vite europea (Vitis vinifera) della varietà desiderata
L’innesto permette di combinare la resistenza del portainnesto con le caratteristiche qualitative della marza, creando una pianta robusta e produttiva.
Per talea
Questa tecnica consiste nel prelevare un pezzo di tralcio (la talea) dalla pianta madre e farlo radicare. La talea deve avere almeno due gemme e viene interrata verticalmente. La parte inferiore emetterà le radici, mentre quella superiore svilupperà un germoglio.
Le viti ottenute per talea sono a “piede franco”, ovvero con radici proprie.
Per propaggine
È un metodo meno comune rispetto ai precedenti, ma efficace per chi non ha esperienza. Consiste nel piegare un tralcio della pianta madre e interrarne una parte senza staccarlo completamente. Il tralcio interrato svilupperà radici e, dopo uno o due anni, potrà essere separato dalla pianta madre diventando esso stesso una nuova pianta.
Per seme (vinaccioli)
La riproduzione sessuata tramite i semi (i vinaccioli dell’uva) non viene quasi mai utilizzata in viticoltura commerciale. Il motivo principale è che i semi non garantiscono la fedeltà genetica: le piante nate da seme non avranno le stesse caratteristiche della pianta madre. Potrebbero risultare molto diverse e non avere le qualità desiderate per la produzione di vino o uva da tavola.
La riproduzione per seme è invece fondamentale per la ricerca e la selezione di nuove varietà di vitigni.
Semi
I semi della pianta della vite, chiamati vinaccioli, si trovano all’interno della polpa dell’acino d’uva.
Sono di piccole dimensioni, generalmente di forma ovoidale, e presentano una consistenza dura e legnosa. Il loro colore può variare dal verde chiaro al marrone scuro, a seconda del grado di maturazione dell’uva.
Dal punto di vista della composizione, i vinaccioli sono ricchi di:
- Tannini: si tratta di composti polifenolici che conferiscono una sensazione di astringenza e amaro. Durante la produzione del vino, il rilascio di questi tannini dai vinaccioli contribuisce a definire la struttura e il carattere del prodotto finale
- Oli: i semi dell’uva contengono una buona percentuale di olio (noto come olio di vinaccioli), che è apprezzato per le sue proprietà antiossidanti e il suo contenuto di acidi grassi essenziali, come l’acido linoleico
- Altri composti: sono presenti anche sostanze glucidiche, proteiche e minerali
I vinaccioli, quindi, sono una parte molto importante dell’acino, non solo per la riproduzione della pianta, ma anche per le loro proprietà, sfruttate sia in campo enologico che in ambito alimentare e cosmetico.
Informazioni e curiosità
Una distinzione fondamentale che si può fare nel mondo dell’uva è quella tra uva da vino e uva da tavola.
Sebbene entrambe provengano dalla stessa specie di pianta (la Vitis vinifera), si differenziano per le caratteristiche fisiche e la composizione chimica, che le rendono adatte a scopi diversi.
Uva da tavola
Viene selezionata per essere consumata fresca. Le sue caratteristiche principali sono:
- Acini grandi e consistenti: hanno una polpa più compatta, soda e carnosa
- Buccia sottile: è facile da masticare e digerire
- Sapore dolce e meno acido: contiene un elevato grado zuccherino e una bassa acidità, rendendola piacevole al palato
- Pochi semi (o assenti): esistono molte varietà apirene, cioè senza semi, per un consumo più agevole
- Aspetto estetico: i grappoli sono generalmente grandi, ben formati e di bell’aspetto
Esempi di uva da tavola sono l’Italia, la Red Globe, la Pizzutella e la Victoria.
Uva da vino
Viene coltivata specificamente per la produzione di vino. Le sue caratteristiche sono ottimizzate per il processo di vinificazione:
- Acini piccoli: hanno una maggiore superficie rispetto al volume, il che concentra più polifenoli (tannini e antociani), aromi e acidi nella buccia
- Buccia spessa: contiene un’alta concentrazione di tannini, che contribuiscono alla struttura e alla longevità del vino, e di antociani, che conferiscono il colore ai vini rossi
- Polpa succosa: la polpa è meno soda rispetto a quella da tavola e ha una consistenza più acquosa, pronta per essere pigiata e trasformata in mosto
- Sapore più aspro e complesso: l’equilibrio tra zuccheri e acidi è fondamentale per la fermentazione e per l’invecchiamento del vino. L’acidità è una caratteristica essenziale che garantisce la freschezza e la conservazione
- Molti semi (vinaccioli): i semi contengono tannini che vengono rilasciati durante la macerazione e la fermentazione, contribuendo alla struttura del vino
Coltivazione
Oltre alla piena terra, è possibile coltivare la vite anche in vaso, ma è importante sapere che richiede cure specifiche e non ci si deve aspettare una produzione di uva paragonabile a quella di un vigneto in piena terra. Tuttavia, può dare ottimi risultati e regalare la soddisfazione di raccogliere gustosi grappoli sul proprio balcone o terrazzo.
La scelta del contenitore è fondamentale: la pianta della vite ha un apparato radicale profondo, quindi il vaso deve essere il più grande e profondo possibile. Un vaso di almeno 50-60 cm di diametro e profondità è un buon punto di partenza. È fondamentale che abbia fori di drenaggio adeguati per evitare ristagni d’acqua.
Si consiglia di utilizzare un terriccio universale di buona qualità, eventualmente miscelato con sabbia per migliorare il drenaggio. Sul fondo del vaso, è opportuno creare uno strato di argilla espansa, ghiaia o cocci per facilitare lo sgrondo dell’acqua in eccesso.
Essendo un rampicante, la vite ha bisogno anche di un supporto per crescere. Un traliccio, una pergola o un semplice palo robusto sono indispensabili.
Sebbene molte varietà possano essere coltivate in vaso, alcune si adattano meglio di altre. Ad esempio, la Vitis labrusca, comunemente nota come uva fragola, è spesso raccomandata per la sua resistenza alle malattie e la sua adattabilità alla coltivazione in contenitore. È consigliabile scegliere varietà da tavola per il consumo diretto.
Collocazione
Trattandosi di una pianta eliofila, la vite necessita di crescere all’esterno, sia in vaso sia in piena terra.
Concimazione
La concimazione della vite è un’operazione fondamentale per garantire la salute della pianta, la quantità e la qualità della produzione, e la longevità del vigneto.
Le tempistiche e le modalità dipendono da diversi fattori, tra cui il tipo di suolo, le condizioni climatiche, l’età della pianta e il tipo di vino che si intende produrre.
Quando concimare
Generalmente, si distinguono due momenti principali:
- Concimazione autunnale (post-vendemmia): è il periodo ideale per apportare concimi a lento rilascio e sostanze organiche. Dopo la vendemmia, la pianta della vite ha bisogno di reintegrare i nutrienti che ha utilizzato per la produzione dei grappoli e di accumulare riserve per la stagione successiva. Si utilizzano concimi organici come letame, compost o humus di lombrico, che migliorano la struttura del suolo e lo arricchiscono lentamente. In questa fase si possono anche apportare concimi minerali ricchi di fosforo e potassio, elementi importanti per la lignificazione dei tralci e per la resistenza della pianta al freddo.
- Concimazione primaverile (ripresa vegetativa): in primavera, la vite ha un fabbisogno elevato di nutrienti, in particolare di azoto, per sostenere la rapida crescita dei germogli e lo sviluppo delle foglie. Si possono usare concimi minerali a rapida assimilazione o concimi organici che rilasciano azoto in modo graduale. La concimazione in questa fase aiuta la pianta a prepararsi per la fioritura e l’allegagione.
È importante notare che, al di là delle considerazioni generali, ogni intervento di concimazione andrebbe sempre basato su un’analisi del suolo, che permette di conoscere le reali carenze nutritive e di dosare i fertilizzanti in modo mirato, evitando sprechi e danni all’ambiente.
Come concimare
Le modalità di concimazione variano in base al tipo di fertilizzante e alle esigenze del vigneto:
- Concimazione al suolo: è il metodo più comune. I concimi (organici o minerali) vengono distribuiti direttamente sul terreno, a spaglio o localizzati alla base della pianta, per essere assorbiti dalle radici
- Concimazione fogliare: in questo caso, i nutrienti (spesso microelementi come boro, magnesio, ferro) vengono disciolti in acqua e irrorati direttamente sulle foglie. Questo metodo è utile per correggere rapidamente carenze specifiche, ma non può sostituire la concimazione al suolo
- Fertirrigazione: utilizzata in vigneti con impianto di irrigazione a goccia, consiste nel disciogliere i concimi nell’acqua di irrigazione, permettendo un apporto costante e mirato di nutrienti durante le fasi di crescita attiva
Tipi di concimi
- Concimi organici: letame, compost, humus. Migliorano la struttura del suolo e forniscono nutrienti in modo graduale e duraturo
- Concimi minerali: apportano specifici elementi nutritivi come azoto (N), fosforo (P) e potassio (K), i cosiddetti “macroelementi” essenziali. Sono disponibili in diverse formulazioni, a cessione rapida o lenta
- Microelementi: sono nutrienti di cui la pianta della vite ha bisogno in quantità ridotte (boro, zinco, manganese, ecc.), ma la cui carenza può compromettere gravemente la crescita e la produzione. Spesso vengono somministrati tramite concimazione fogliare
Esposizione e luce
L’esposizione ideale per la pianta della vite è il pieno sole.
Si tratta, infatti, di una pianta eliofila, cioè amante della luce solare, che ha bisogno di molte ore di sole diretto per crescere in modo sano e produrre uva di qualità.
Per questo motivo, l’esposizione a sud è spesso considerata la migliore, specialmente in climi più freschi; anche un’esposizione a sud-est o a sud-ovest è eccellente, mentre l’esposizione a nord è generalmente da evitare in quanto la luce solare è insufficiente.
Anche nel caso della coltivazione in vaso, è essenziale posizionare il contenitore in un punto del balcone o del terrazzo che riceva il massimo sole possibile.
Annaffiatura
La vite è considerata una pianta tollerante ai periodi di siccità. Tuttavia, gli esemplari giovani con apparato radicale meno sviluppato sono più vulnerabili e richiedono un adeguato apporto idrico.
Le esigenze idriche, inoltre, variano significativamente con le fasi vegetative: sono massime durante lo sviluppo degli acini, intermedie in fase di maturazione e minime al momento della vendemmia.
1. Piante giovani
Le viti nei primi anni di vita necessitano di annaffiature regolari per sviluppare un apparato radicale robusto.
- Subito dopo l’impianto: annaffiare abbondantemente (10-15 litri per pianta) per favorire l’adesione del terreno alle radici ed eliminare le sacche d’aria
- Primo anno: durante i mesi più caldi e secchi (da giugno ad agosto), annaffiare 1-2 volte a settimana, fornendo circa 5-10 litri d’acqua per pianta
- Dal secondo anno in poi: ridurre progressivamente le annaffiature, intervenendo solo in periodi di siccità prolungata
2. Viti adulte e in produzione
Le viti adulte, con radici ben sviluppate, sono molto più resistenti alla siccità. Spesso l’irrigazione non è necessaria se il clima è temperato, ma diventa un’operazione di soccorso in caso di estati particolarmente calde e secche.
L’annaffiatura deve essere mirata a soddisfare le esigenze idriche della pianta nelle fasi cruciali, ossia:
- Germogliamento, fioritura e allegagione: in queste fasi, la carenza d’acqua può compromettere la produzione
- Invaiatura e maturazione: durante la maturazione, l’irrigazione viene generalmente sospesa o ridotta al minimo. Un eccesso d’acqua in questa fase può, infatti, diluire gli zuccheri e gli aromi, compromettendo la qualità dell’uva
Fattori ambientali da considerare
Altri aspetti da valutare per stabilire la frequenza dell’irrigazione sono:
Tipo di terreno
- Terreni argillosi: trattengono l’acqua più a lungo, richiedendo annaffiature meno frequenti ma più abbondanti
- Terreni sabbiosi: drenano rapidamente l’acqua, necessitando di annaffiature più frequenti e con minori quantità
Clima
- Caldo e secco: l’irrigazione è spesso indispensabile
- Clima temperato: potrebbe non essere necessaria, a meno di periodi di siccità prolungata
L’irrigazione a goccia è il metodo più efficiente per annaffiare la vite poiché consente di fornire l’acqua direttamente all’apparato radicale, riducendo gli sprechi per evaporazione e il rischio di comparsa di malattie fungine sul fogliame.
Di contro, evitare l’irrigazione a pioggia: bagna il fogliame e i grappoli, favorendo l’insorgere di malattie come la peronospora e l’oidio.
Potatura
La potatura della pianta della vite è una pratica essenziale per ottimizzare la quantità e la qualità dell’uva prodotta.
Esistono diverse tipologie di potatura, che si applicano in momenti diversi del ciclo annuale della vite:
Potatura di allevamento
Viene applicata nei primi anni di vita della pianta con l’obiettivo di determinare la sua “forma” definitiva e la struttura permanente. La forma che la vite assumerà dipende da come viene condotta e potata durante il suo sviluppo iniziale.
Potatura di produzione (o annuale/secca)
Questa è un’operazione che si esegue annualmente durante il riposo vegetativo della pianta (inverno, dopo la vendemmia e prima del germogliamento).
Consiste nell’eliminazione di circa l’80-90% del legno prodotto l’anno precedente. L’obiettivo è stabilire il numero di gemme da lasciare sulla pianta, da cui poi nasceranno i grappoli.
La potatura di produzione regola la quantità di uva: lasciando più gemme si ottiene più uva, ma con una minore concentrazione di aromi e zuccheri. Inoltre, favorisce la maturazione assicurando che i grappoli ricevano la luce necessaria e migliora la circolazione dell’aria, riducendo il rischio di malattie.
Potatura verde
Questa serie di operazioni si svolge durante la fase vegetativa della pianta (primavera/estate). Include diverse pratiche:
- Spollonatura: eliminazione dei polloni (germogli non produttivi) che nascono dal tronco o dal legno vecchio, per concentrare le energie sui germogli produttivi
- Scacchiatura: rimozione dei germogli in eccesso sul capo a frutto (il tralcio dell’anno precedente che viene selezionato per portare la produzione di uva nell’anno corrente)
- Sfemminellatura: eliminazione delle femminelle (germogli laterali poco produttivi) che competerebbero con il germoglio fruttifero principale
- Cimatura: rimozione degli apici dei germogli che sono cresciuti oltre la struttura di supporto, per contenere la chioma e favorire la maturazione del legno
- Sfogliatura: eliminazione di alcune foglie intorno ai grappoli per garantire maggiore ventilazione ed esposizione alla luce, migliorando la maturazione e riducendo il rischio di muffe
- Diradamento: per la produzione di vini di pregio, alcuni produttori rimuovono parte o tutti i grappoli in eccesso per concentrare le risorse della pianta e accentuare l’intensità aromatica del frutto
Rinvaso e trapianto
Il trapianto della vite è un’operazione delicata: per garantire il successo dell’attecchimento e la futura produttività della pianta, è essenziale seguire una serie di passaggi precisi, dalla scelta del periodo ideale per la messa a dimora di un filare alle cure post-trapianto.
Il periodo più propizio è durante il riposo vegetativo, che va dalla fine dell’inverno all’inizio della primavera (indicativamente tra novembre e marzo). In questa fase, la pianta ha perso le foglie e l’attività linfatica è ridotta al minimo, il che le permette di subire meno stress e di concentrare le energie nello sviluppo di nuove radici una volta messa a dimora.
Preparazione della vite: potatura di radici e chioma
Prima del trapianto, è cruciale preparare adeguatamente la vite per favorirne l’adattamento alla nuova posizione.
- Apparato radicale: le radici della vite da trapiantare devono essere accorciate. Questa operazione, da eseguire con forbici da potatura ben affilate e disinfettate, stimola l’emissione di nuove radici capillari, fondamentali per l’assorbimento di acqua e nutrienti. Si consiglia di lasciare le radici principali lunghe circa 10-15 cm
- Parte aerea: è altrettanto importante ridurre la parte aerea della pianta per creare un equilibrio con l’apparato radicale ridotto. In genere, si seleziona il tralcio più robusto e lo si accorcia lasciando 2-3 gemme. Questo limiterà la traspirazione e consentirà alla vite di indirizzare le sue risorse verso lo sviluppo radicale
Preparazione della buca e del terreno
La buca che ospiterà la vite dovrebbe essere significativamente più grande del volume delle radici della pianta, idealmente larga e profonda almeno 50×50 cm, se non di più.
Sul fondo della buca è fondamentale creare uno strato drenante con ghiaia o argilla espansa per evitare ristagni idrici, molto dannosi per le radici della vite. Sopra lo strato drenante, è consigliabile aggiungere del concime organico ben maturo, come letame o compost, mescolandolo con un po’ di terra. Questo fornirà un nutrimento graduale e a lungo termine.
Il trapianto step by step
- Posizionamento: adagiare uno strato di terra sopra il concime per evitare il contatto diretto con le radici. Posizionare la vite al centro della buca, assicurandosi che il punto d’innesto (il rigonfiamento sul fusto da cui partono i tralci) si trovi almeno 5-7 cm sopra il livello del terreno. Questo è di vitale importanza per prevenire l’emissione di radici dal nesto (la parte superiore all’innesto), che indebolirebbe la pianta
- Rincalzo: riempire la buca con la terra precedentemente scavata, sminuzzandola finemente per evitare la formazione di sacche d’aria. Comprimere leggermente il terreno con le mani, o con i piedi, man mano che si riempie la buca
- Sostegno: è consigliabile installare un tutore (una canna o un palo) a fianco della vite per sostenerla durante la crescita e guidare lo sviluppo del fusto in modo eretto
Cure post-trapianto
Le prime settimane e i primi mesi dopo il trapianto sono critici per la sopravvivenza della vite e due operazioni sono essenziali da eseguire.
- Irrigazione: subito dopo il trapianto, è indispensabile procedere con un’abbondante irrigazione per far aderire bene la terra alle radici ed eliminare eventuali bolle d’aria. Successivamente, il terreno dovrà essere mantenuto costantemente umido, ma non zuppo. La frequenza delle irrigazioni dipenderà dal clima e dal tipo di terreno; in assenza di piogge, è bene controllare il terreno e annaffiare quando i primi centimetri si presentano asciutti
- Concimazione: per le prime settimane, la vite attingerà alle riserve nutritive del terreno e del concime di fondo. Dopo circa 8-10 giorni, quando la pianta avrà superato lo stress iniziale, si potrà iniziare a somministrare un concime liquido bilanciato (ternario con microelementi) ogni 15 giorni circa durante la stagione vegetativa, per sostenere la crescita
Ubicazione stagionale
La pianta della vite ha esigenze termiche specifiche che variano a seconda della fase del suo ciclo vegetativo.
L’intervallo di temperatura ideale per la crescita e la produzione di uva di qualità è compreso generalmente tra i 16°C e i 35°C. Tuttavia, le temperature ottimali cambiano in base al periodo dell’anno e alle diverse fasi di sviluppo della pianta.
- Dormienza invernale: durante l’inverno, la vite ha bisogno di un periodo di riposo a temperature inferiori a 7°C per prepararsi alla crescita della stagione successiva. Le temperature non dovrebbero scendere al di sotto di -15°C/-18°C per evitare danni
- Germogliamento: la ripresa vegetativa inizia quando le temperature superano gli 8-12°C
- Fioritura: per una fioritura ottimale e la vitalità del polline, sono necessarie temperature tra i 17°C e i 22°C, con un massimo ideale intorno ai 27-28°C. Temperature superiori a 30-35°C possono danneggiare il polline
- Crescita e maturazione dell’uva: prima dell’invaiatura (il momento in cui gli acini cambiano colore), le temperature ideali sono tra i 22°C e i 25°C; dall’invaiatura alla maturazione, le temperature ottimali sono tra i 22°C e i 28°C. nella fase della vendemmia, le temperature ideali si attestano tra i 17°C e i 23°C
È importante notare che, oltre alla temperatura media, anche le escursioni termiche (la differenza tra la temperatura diurna e quella notturna) giocano un ruolo cruciale nella maturazione degli zuccheri e nello sviluppo degli aromi nell’uva. Temperature diurne elevate e notti più fresche possono favorire una maturazione armoniosa e una migliore qualità del vino.
Infine, la vite è particolarmente sensibile agli estremi termici. Temperature troppo elevate, specialmente se persistenti (oltre i 35°C), possono causare stress termico, arresto della crescita, precoce invecchiamento dei tessuti e compromettere la qualità dell’uva.
Allo stesso modo, le gelate tardive in primavera possono danneggiare gravemente i germogli, mentre le gelate precoci in autunno possono compromettere i frutti.
Raccolta
La raccolta dell’uva, ovvero la vendemmia, è un momento cruciale nel ciclo produttivo del vino e la sua tempistica e modalità dipendono da diversi fattori.
Il momento ideale, infatti, cambia a seconda del tipo di uva, del clima e del tipo di vino che si intende produrre, anche se, generalmente, si possono distinguere tre periodi:
- Agosto-settembre: per le uve a maturazione precoce o medio-precoce
- Settembre-ottobre: per le uve a maturazione media
- Ottobre-novembre: per le uve a maturazione tardiva
Inoltre, la decisione su quando vendemmiare si basa su un’attenta valutazione di diversi aspetti, tra cui:
- Maturazione tecnologica: riguarda l’equilibrio tra zuccheri e acidi nell’uva. Durante la maturazione, la concentrazione di zuccheri aumenta, mentre quella degli acidi diminuisce. Il rapporto ideale varia a seconda del vino desiderato
- Maturazione fenolica: si riferisce alla concentrazione di sostanze fenoliche, responsabili del colore e della struttura del vino (tannini e antociani)
- Maturazione aromatica: riguarda lo sviluppo delle sostanze aromatiche che si concentrano nelle bucce
Questi parametri vengono spesso monitorati attraverso analisi in laboratorio e, in modo più tradizionale, tramite un’analisi sensoriale (visiva, tattile e gustativa) degli acini.
Come si raccoglie l’uva
Esistono due metodi principali:
- Raccolta manuale: è il metodo più antico e tradizionale, che garantisce un’accurata selezione dei grappoli. Viene eseguita con l’uso di coltelli o cesoie e permette di scartare i grappoli non maturi o danneggiati. La vendemmia manuale è spesso preferita per la produzione di vini di alta qualità, spumanti o vini passiti, dove è richiesta una cernita selettiva
- Raccolta meccanica: utilizza macchinari specifici che scuotono la vite per far cadere gli acini maturi. È un metodo molto più veloce ed economico rispetto a quello manuale, ma non permette una selezione accurata dei grappoli e può danneggiare gli acini. Viene impiegato soprattutto nei vigneti più estesi e per produzioni di vini di media qualità
Indipendentemente dal metodo scelto, è fondamentale raccogliere l’uva in condizioni ottimali, evitando le ore più calde della giornata per prevenire fermentazioni indesiderate e trasportandola rapidamente in cantina per l’inizio del processo di vinificazione.
Malattia e cure
La pianta della vite può essere colpita da diverse malattie, principalmente di origine fungina, batterica o virale. La cura varia notevolmente a seconda del patogeno e si basa spesso su un approccio integrato che combina prevenzione e trattamenti mirati.
Malattie fungine
Sono le più comuni e dannose per la vite, poiché prosperano in ambienti umidi.
Peronospora
- Sintomi: si formano macchie traslucide sulle foglie che diventano gialle e necrotiche; sulla pagina inferiore compare una muffa biancastra; sui grappoli causa il disseccamento degli acini, che si ripiegano a formare una “S”
- Cura: la prevenzione è fondamentale e si basa su trattamenti a base di rame (come la poltiglia bordolese) o fungicidi sistemici, specialmente dopo piogge intense e in condizioni favorevoli allo sviluppo del fungo
Oidio
- Sintomi: una polverina bianca, simile a cenere, ricopre foglie, tralci e acini. Le foglie si arricciano e cadono prematuramente, mentre i grappoli colpiti si spaccano
- Cura: si combatte con trattamenti a base di zolfo, sia in polvere che in formulazioni bagnabili. In viticoltura biologica si usano anche prodotti a base di bicarbonato di potassio
Botrite
- Sintomi: conosciuta come “muffa grigia”, attacca i grappoli, facendoli marcire. Si manifesta, appunto, con una muffa grigiastra che si sviluppa sugli acini danneggiati
- Cura: si previene con una corretta gestione del vigneto, ad esempio attraverso potature che favoriscano l’aerazione e la luce. In caso di attacco, si usano fungicidi specifici
Malattie batteriche
Sono meno comuni delle fungine, ma possono essere altrettanto pericolose.
Mal dell’esca
- Sintomi: si tratta di una malattia complessa che porta a un progressivo deperimento della pianta della vite, con imbrunimento del legno e alterazioni delle foglie (striature gialle o rosse). Non ha una manifestazione univoca e può portare alla morte improvvisa della pianta
- Cura: non esiste una cura definitiva. La strategia migliore è la prevenzione, che include la scelta di portainnesti sani, la disinfezione degli attrezzi da potatura e l’eliminazione delle piante infette. In agricoltura biologica si utilizzano microrganismi utili come il Trichoderma
Malattie virali
Sono le più difficili da gestire perché non esistono cure dirette. Vengono trasmesse principalmente da insetti vettori o tramite materiale vegetale infetto.
Accartocciamento fogliare
- Sintomi: le foglie si accartocciano verso il basso e diventano di colore rosso o giallo a seconda del vitigno, mentre le nervature rimangono verdi. Questo riduce la fotosintesi e la qualità dell’uva
- Cura: poiché non esiste un trattamento curativo, la prevenzione è l’unica via e si basa sull’uso di materiale di propagazione certificato e sano e sulla lotta contro gli insetti vettori, come le cocciniglie