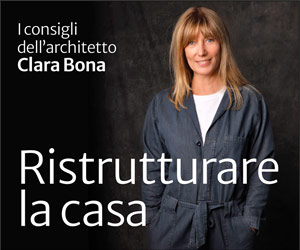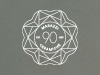- Fioritura
- Commestibilità
- Riproduzione
- Semi
- Informazioni e curiosità
- Coltivazione
- Collocazione
- Concimazione
- Esposizione e luce
- Annaffiatura
- Potatura
- Rinvaso e trapianto
- Ubicazione stagionale
- Malattia e cure

- L’eleagnus è una pianta da esterno, anche da siepe, estremamente resistente e facile da coltivare anche per i principianti.
- Il bellissimo fogliame verde intenso di Elaeagnus X ebbingei “Compacta”.
- L’eleagnus produce piccole bacche rosse in primavera, molto gradite soprattutto agli uccelli.
- Un esemplare isolato di eleagnus angustifolia.
- Alcune varietà di eleagno producono foglie variegate, come Elaeagnus x ebbingei “Gilt Edge”.
- Un bellissimo esemplare di eleagnus multiflora.
L’eleagnus (genere Elaeagnus) è un gruppo di piante appartenenti alla famiglia delle Elaeagnaceae, che comprende arbusti e piccoli alberi, sia sempreverdi che decidui, molto apprezzati per la loro robustezza e versatilità, in particolare per la creazione di siepi.
La specie più diffusa e utilizzata in Italia è l’elaeagnus x ebbingei (un ibrido tra elaeagnus macrophylla e elaeagnus pungens), che è un arbusto sempreverde dal portamento eretto e compatto.
La maggior parte degli eleagnus sono arbusti densi e ramificati e possono raggiungere i 2-4 metri di altezza, e anche una larghezza simile. La crescita è mediamente rapida, soprattutto per le varietà da siepe.
Le foglie sono una delle caratteristiche più distintive: al tatto risultano robuste, con una pagina superiore generalmente verde scuro lucido, mentre la pagina inferiore è argentea, spesso punteggiata di bruno o con riflessi metallici, dovuti a piccole squame. Questa differenza di colore crea un bellissimo contrasto quando le foglie si muovono al vento.
La forma è lanceolata o ellittica, con margine intero, a volte leggermente ondulato. Esistono cultivar con foglie variegate, ad esempio con margini gialli o dorati (Gilt Edge, Eleador, Limelight).
Il periodo di fioritura coincide principalmente con l’autunno (settembre-novembre) e porta alla produzione di fiori piccoli, poco appariscenti ma intensamente profumati, di colore bianco-crema o argentato, spesso penduli e raggruppati all’ascella delle foglie.
Dopo la fioritura, la pianta produce piccole bacche ovali o rotonde, in alcune specie commestibili (elaeagnus x ebbingei ed elaeagnus umbellata), dolciastre e ricche di vitamine e minerali.
Per quanto riguarda le regole di coltivazione, l’eleagnus è una pianta incredibilmente rustica e quindi, una volta adattata, richiede davvero poca manutenzione.
Si adatta a diversi tipi di terreno, anche poveri, aridi, calcarei o sabbiosi, purché ben drenati (soffre i ristagni idrici), e cresce bene sia in pieno sole che in mezz’ombra. Sopporta senza problemi le potature e anche gli apporti idrici e di nutrienti sono minimi.
Tollerante alla salsedine (è una pianta ideale per giardini costieri e zone vicino al mare), all’inquinamento e al vento, resiste a temperature invernali considerevoli (fino a -10°C/-15°C e oltre, a seconda della specie).
Fioritura
La maggior parte delle specie di eleagnus, inclusa elaeagnus x ebbingei, fiorisce in autunno, generalmente da settembre a novembre.
Anche se i fiori di eleagnus sono spesso piccoli e non appariscenti come quelli di altre piante ornamentali, hanno una caratteristica molto apprezzata: sono estremamente profumati.
Più nello specifico, i fiori sono piccoli, spesso tubulari o a forma di campanella, di colore bianco-crema o argentato e con un intenso e dolce profumo, che si diffonde nell’aria, soprattutto nelle ore serali o nelle giornate più umide. Questo profumo attrae molto le api e altri insetti impollinatori.
Dopo la fioritura, l’eleagnus produce delle piccole bacche ovali che maturano in primavera. Inizialmente sono verdi-argentee, come delle olive, e poi diventano rosso-arancio a maturità. Questi frutti sono commestibili (anche se spesso un po’ astringenti se non ben maturi) e sono molto apprezzati dagli uccelli.
Commestibilità
Riproduzione
L’eleagnus si riproduce in diversi modi, anche se la talea è generalmente il metodo più comune e affidabile per i giardinieri amatoriali e i vivaisti.
Talea
Ricorrendo alle talee si ottengono nuove piante di eleagnus identiche alla pianta madre e si possono usare diversi tipi di talee a seconda del periodo:
Talea semi-legnosa (raccomandata eleagnus x ebbingei)
Si preleva da fine estate a inizio autunno (agosto-ottobre), quando i fusti dell’anno corrente hanno iniziato a lignificare alla base ma sono ancora morbidi in punta.
Il procedimento da seguire è questo:
- Prelevare le talee: scegliere germogli sani e vigorosi, lunghi circa 10-15 cm
- Preparare le talee: rimuovere le foglie dalla parte inferiore per circa un terzo o metà della lunghezza della talea (se le foglie superiori sono molto grandi, tagliarle a metà per ridurre la traspirazione). Effettuare un taglio netto appena sotto un nodo (il punto dove le foglie si attaccano al fusto)
- Usare un ormone radicante: immergere la base della talea in un ormone radicante in polvere o gel per aumentare le probabilità di successo
- Mettere a dimora: inserire le talee in un substrato leggero e ben drenante, come una miscela di torba e perlite (o sabbia grossolana) in parti uguali. Assicurarsi che almeno un nodo sia interrato
- Scegliere l’ambiente giusto: collocare il contenitore in un ambiente caldo (temperatura del substrato ideale tra 18-24°C), luminoso ma non in pieno sole diretto, e con elevata umidità. Si può coprire il vaso con un sacchetto di plastica trasparente o metterlo in una mini serra per mantenere l’umidità
- Cura: mantenere il substrato costantemente umido ma non inzuppato. Le radici dovrebbero formarsi in 6-8 settimane
Talea legnosa
Occorre prelevare rami lignificati di circa 15-25 cm nel tardo autunno o in inverno (novembre-febbraio), quando la pianta di eleagnus è in riposo vegetativo e i rami sono completamente lignificati.
La radicazione della talea legnosa potrebbe richiedere più tempo (fino a 3-4 mesi o anche di più) e una maggiore percentuale di insuccesso rispetto alla precedente.
Volendo, è possibile ricorrere anche alla talea erbacea, in tarda primavera o inizio estate (maggio-giugno), ma servono condizioni di umidità molto elevate per farla radicare e non è detto che la riproduzione abbia successo.
Margotta
La margotta è un metodo in cui si induce un ramo a emettere radici mentre è ancora attaccato alla pianta madre.
Generalmente, si esegue in primavera o inizio estate e consiste nell’incidere un anello di corteccia su un ramo sano, applicare un ormone radicante e avvolgere la zona con muschio umido o terriccio, il tutto coperto da un involucro di plastica. Una volta radicato, il ramo viene tagliato e piantato.
Divisione dei polloni
Alcune specie di eleagnus (come elaeagnus angustifolia o elaeagnus umbellata) tendono a produrre polloni (germogli che nascono dalla base della pianta madre o dalle radici). Questi possono essere separati dalla pianta madre con parte del loro apparato radicale e trapiantati.
Generalmente, questa operazione si esegue in autunno o a fine inverno, quando la pianta è a riposo.
Anche la riproduzione da seme è possibile, ma è un processo più lento e meno prevedibile, soprattutto perché i semi di eleagnus hanno spesso una dormienza che richiede specifici trattamenti per la germinazione.
In sintesi, considerando la facilità, la velocità e la fedeltà varietale, al di là dei vari metodi di riproduzione possibili, le talee semi-legnose sono il metodo più consigliato per riprodurre l’eleagnus.
Semi
I semi della pianta di eleagnus sono contenuti all’interno delle bacche (o pseudodrupe) che la pianta produce dopo la fioritura.
Ogni bacca contiene un singolo seme, un “nocciolo” di forma ovale o ellittica, racchiuso da un pericarpo membranaceo o legnoso, a seconda della specie. Spesso questo rivestimento può essere duro o coriaceo.
Il colore del seme è solitamente chiaro, tendente al beige o al marrone chiaro e tende a presentarsi oleoso.
Informazioni e curiosità
Il nome particolare Elaeagnus deriva dal greco e si riferisce all’aspetto lucido, argentato e oleoso del suo fogliame.
Coltivazione
Oltre che in piena terra in giardino, come esemplare isolato o per creare una siepe, la pianta di eleagnus si può coltivare anche in vaso: la sua robustezza e adattabilità lo rendono adatto a vivere in contenitore, a patto di seguire alcune accortezze.
In vaso, però, la crescita dell’eleagnus è naturalmente più contenuta rispetto alla piena terra, ma anche più facile da gestire e mantenere delle dimensioni desiderate.
Per quanto riguarda la scelta del contenitore, si consiglia di optare per uno di dimensioni generose fin da subito. Un eleagnus giovane può iniziare a crescere in un vaso da 30-40 cm di diametro, ma avrà bisogno di rinvasi in contenitori progressivamente più grandi (fino a 60-80 cm di diametro o più) man mano che cresce.
Inoltre, il vaso dovrebbe essere pesante e stabile (per evitare che la pianta si rovesci con il vento, soprattutto quando diventa più grande) e dotato di fori di drenaggio ampi e abbondanti sul fondo per scongiurare il rischio di ristagni d’acqua.
A questo scopo, si rivela utile anche aggiungere del materiale drenante sul fondo come argilla espansa e ghiaia.
Collocazione
Data la sua resistenza e rusticità, la pianta di eleagnus si coltiva all’esterno senza problemi, complice anche l’adattabilità alle basse temperature.
Concimazione
L’eleagnus è una pianta molto resistente e poco esigente in fatto di concimazione, ma un’adeguata integrazione di nutrienti può favorire una crescita più vigorosa, un fogliame più lucido e una maggiore densità, soprattutto se coltivato in condizioni non ottimali o come siepe per ottenere un effetto coprente.
- Fine inverno/inizio primavera (febbraio – marzo – aprile): questo è il momento più importante. Fornire nutrienti in questa fase aiuta la pianta a riprendere una crescita vigorosa dopo il riposo invernale e a prepararsi per la nuova stagione vegetativa.
- Metà primavera (aprile – maggio): se si desidera una spinta ulteriore alla crescita o se il terreno è particolarmente povero, si può fare una seconda concimazione a lenta cessione.
- Inizio autunno (settembre – ottobre): in alcune regioni con clima mite, una concimazione leggera all’inizio dell’autunno può essere utile per rafforzare l’eleagnus in vista dell’inverno e aiutarlo a immagazzinare riserve. Tuttavia, è importante che i nuovi germogli abbiano il tempo di lignificare prima dell’arrivo del freddo intenso, per evitare danni da gelo.
L’eleagno beneficia di concimi bilanciati, ma con una leggera predilezione per l’azoto (N), che favorisce lo sviluppo del fogliame.
- Concime granulare a lenta cessione: è l’opzione più comoda per le piante coltivate in piena terra o per le siepi perché rilascia gradualmente i nutrienti nel terreno per un periodo prolungato. Un concime NPK bilanciato (come 10-10-10) o con un rapporto leggermente più alto di azoto (come 10-6-4) è l’ideale. Si distribuisce uniformemente intorno alla base della pianta, lontano dal fusto, e lo si incorpora leggermente nel terreno. Successivamente, annaffiare abbondantemente per favorire lo scioglimento dei granuli e l’assorbimento dei nutrienti.
- Concime organico: compost maturo o stallatico ben decomposto sono ottimi per migliorare la struttura e la fertilità generale del terreno. Possono essere incorporati nel terreno a fine inverno/inizio primavera.
Un diverso discorso riguarda le piante di eleagnus coltivate in vaso, dal momento che le riserve di nutrienti nel terriccio del contenitore si esauriscono più velocemente.
In questo caso, un concime liquido per piante verdi, diluito nell’acqua di irrigazione, somministrato ogni 15 giorni in primavera-estate e una volta al mese in autunno-inverno, è una buona soluzione.
Esposizione e luce
L’eleagnus (in particolare l’elaeagnus x ebbingei, il più comune in Italia) è una pianta estremamente versatile e tollerante per quanto riguarda l’esposizione al sole.
Anche se cresce al meglio in pieno sole (l’esposizione ideale per una crescita più densa e compatta e per ottenere il massimo della fioritura e della produzione di frutti), si adatta molto bene anche alla mezz’ombra.
Evitare comunque l’ombra densa e profonda, specialmente per le specie variegate.
Annaffiatura
L’eleagnus è una pianta che, una volta ben stabilita, è incredibilmente resistente alla siccità. Ciò significa che non richiede annaffiature frequenti, soprattutto se coltivata in piena terra.
Eleagnus appena piantato
Potatura
Mantenere la forma e le dimensioni desiderate è il motivo principale per effettuare la potatura, specialmente se l’eleagnus è utilizzato per siepi, bordure o in spazi limitati. Senza potatura, può diventare molto grande e disordinato.
Inoltre, lo sfoltimento dei rami, stimola la pianta a produrre nuovi germogli, rendendo la siepe o l’arbusto più folto e compatto; rimuovere rami secchi, danneggiati o malati previene la diffusione di malattie e favorisce la circolazione dell’aria all’interno della chioma.
Quando potarlo
Il periodo migliore dipende dal tipo di intervento che bisogna effettuare:
Potatura di formazione e mantenimento (per siepi)
Si esegue principalmente a fine inverno/inizio primavera (febbraio-marzo), quando la pianta è ancora in riposo vegetativo, e i tagli stimoleranno una forte ripartenza primaverile.
Una seconda potatura leggera può essere fatta a fine estate/inizio autunno (agosto-settembre) per rifinire la siepe e mantenere la forma. Evitare potature troppo tardive in autunno per non stimolare nuove crescite che potrebbero essere danneggiate dal gelo invernale.
La potatura di mantenimento consiste nel tagliare i rami facendo in modo che la base sia leggermente più larga della cima (a forma di trapezio) per permettere alla luce di raggiungere anche le parti basse della siepe. Rimuovere anche i rami che crescono verso l’interno o che si incrociano, nonché quelli troppo lunghi o fuori misura.
Potatura di pulizia (rimozione rami malati/secchi/danneggiati)
Può essere fatta in qualsiasi momento dell’anno, non appena si notano rami problematici.
Potatura di ringiovanimento
Se la pianta è diventata troppo grande o spogliata alla base, è possibile effettuare una potatura più drastica, riducendo i rami principali anche di un terzo o della metà della loro lunghezza. Questo stimolerà l’eleagnus a emettere nuovi germogli dalla base.
La potatura di ringiovanimento si pratica preferibilmente a fine inverno, prima della ripresa vegetativa, in modo che la pianta abbia tutta la stagione per rigermogliare vigorosamente.
Rinvaso e trapianto
Il periodo ideale per trapiantare l’eleagnus si concentra in due momenti principali dell’anno.
- Inizio primavera: trapiantare all’inizio della stagione vegetativa, quando la pianta sta per riprendere la sua crescita, le permette di stabilire rapidamente le radici nel nuovo terreno prima dell’arrivo del caldo estivo
- Autunno: il periodo tra la fine dell’estate e la metà dell’autunno è un’altra finestra ottimale. Le temperature miti e le piogge più frequenti favoriscono l’attecchimento delle radici in un terreno ancora caldo.
Per le piante di eleagnus coltivate in vaso, il rinvaso si rende necessario ogni 2-3 anni, o quando le radici hanno completamente occupato lo spazio a disposizione. Anche in questo caso, la primavera è il momento più indicato.
Come trapiantare l’eleagnus in piena terra
- Preparazione della pianta: prima di porre a dimora l’eleagnus, è consigliabile potare leggermente i rami secchi o danneggiati. Questo ridurrà lo stress idrico e concentrerà le energie della pianta sullo sviluppo radicale
- Scavo della Buca: la nuova buca dovrà essere larga circa il doppio del diametro della zolla di radici della pianta e profonda quanto la zolla stessa. Questo permetterà alle radici di espandersi facilmente nel terreno circostante
- Estrazione della pianta dal vaso: irrigare abbondantemente l’eleagnus qualche ora prima del trapianto per ammorbidire il terreno. Cercare di prelevare una zolla di terra quanto più ampia e compatta possibile attorno alle radici
- Messa a dimora: posizionare la pianta al centro della buca, assicurandosi che il colletto (il punto di incontro tra le radici e il fusto) sia a livello del terreno circostante. Riempire la buca con terriccio di buona qualità, preferibilmente ben drenante e arricchito con sostanza organica
- Assestamento e irrigazione: comprimere leggermente il terreno attorno alla base della pianta per eliminare le sacche d’aria e annaffiare abbondantemente subito dopo il trapianto per favorire l’adesione del terreno alle radici
Nel caso si stia realizzando una siepe, è consigliabile mantenere una distanza di circa 50-70 cm tra una pianta di eleagnus e l’altra.
Come rinvasare l’eleagnus
- Scelta del vaso: optare per un contenitore leggermente più grande del precedente, con fori di drenaggio adeguati
- Preparazione del substrato: utilizzare un terriccio ben drenante, eventualmente miscelato con sabbia o perlite per migliorare il deflusso dell’acqua
- Estrazione e controllo delle radici: estrarre delicatamente l’eleagnus dal vecchio vaso. Se le radici sono molto fitte e aggrovigliate, è possibile districarle con delicatezza
- Rinvaso: collocare uno strato di materiale drenante (come argilla espansa) sul fondo del nuovo vaso, aggiungere una parte di terriccio fresco e posizionare la pianta. Riempire gli spazi vuoti con altro terriccio, senza interrare il colletto
- Irrigazione: annaffiare con moderazione
Se il nuovo vaso ha già raggiunto le dimensioni massime desiderate, si può optare per il “rinnovamento del terriccio”, ossia rimuovere la pianta dal contenitore, potare leggermente le radici esterne e sostituire parte del terriccio esausto con un nuovo substrato fresco.
Cure post-trapianto
Le settimane successive al trapianto sono fondamentali per la ripresa della pianta.
- Irrigazione: mantenere il terreno costantemente umido, ma non zuppo d’acqua. Controllare regolarmente l’umidità del terreno, soprattutto durante i primi mesi
- Pacciamatura: stendere uno strato di pacciame (corteccia, foglie secche) alla base dell’eleagnus aiuterà a mantenere l’umidità del suolo, a controllare le erbe infestanti e a proteggere le radici dagli sbalzi di temperatura
- Monitoraggio: controllare la pianta per individuare eventuali segni di stress, come foglie ingiallite o appassite. È normale un leggero appassimento iniziale, ma se il problema persiste, verificare che l’irrigazione sia corretta
- Concimazione: evitare di concimare la pianta subito dopo il trapianto e attendere che mostri chiari segni di ripresa (nuovi germogli) prima di somministrare un concime bilanciato, preferibilmente a lento rilascio, durante la primavera successiva
- Protezione: se il trapianto è stato effettuato in autunno, in zone con inverni rigidi, può essere utile proteggere la base della pianta di eleagnus con del tessuto non tessuto o altro materiale pacciamante all’arrivo dei primi freddi
Ubicazione stagionale
L’eleagnus (in particolare Elaeagnus x ebbingei, la specie più comune e robusta) è una pianta estremamente tollerante e adattabile a un’ampia gamma di temperature e climi.
In ogni caso, l’intervallo ottimale per la crescita vigorosa della pianta generalmente si colloca tra i 15°C e i 27°C.
L’eleagnus tollera però bene anche temperature più elevate, fino a circa 35°C, ed è notevolmente resistente al freddo (molte varietà di Eleagnus ebbingei possono sopportare temperature fino a -10°C/-15°C e oltre)
Generalmente, non sono necessarie protezioni speciali dal gelo nei climi temperati. In zone con gelate estreme e prolungate, una pacciamatura alla base può aiutare a proteggere le radici.
Bonsai
L’eleagnus è una specie particolarmente adatta per essere trasformata in bonsai, anche da tenere all’aperto dalla primavera fino a settembre. In particolare, elaeagnus pungens è robusto e facile da gestire.
Malattia e cure
L’eleagnus è noto per la sua notevole resistenza a malattie e parassiti, il che lo rende una scelta a bassa manutenzione per giardini e siepi. Tuttavia, come tutte le piante, non è immune e può occasionalmente essere colpito da alcune problematiche, soprattutto in condizioni di stress o umidità eccessiva.
Malattie fungine
Marciume radicale
È una delle problematiche più serie e spesso letali per l’eleagnus. È causato da funghi che attaccano le radici in condizioni di ristagno idrico (terreno troppo compatto, scarsamente drenante o eccesso di annaffiature).
- Sintomi: ingiallimento e appassimento delle foglie (che spesso rimangono attaccate alla pianta), crescita stentata, rami che seccano progressivamente e, nei casi gravi, disseccamento dell’intera pianta. Le radici appariranno scure e molli.
- Prevenzione: garantire un ottimo drenaggio del terreno è fondamentale. Evitare eccessi di annaffiature, soprattutto in inverno.
Oidio
Una malattia fungina che si manifesta con una patina bianca e polverosa sulle foglie, sui giovani germogli e talvolta anche sui fiori. In casi gravi, la crescita della pianta di eleagnus può risultare compromessa.
Favorita da un clima caldo e umido e dalla scarsa circolazione dell’aria, si contrasta con la rimozione delle parti infette, il miglioramento della circolazione dell’aria, e in casi gravi, trattamenti con fungicidi specifici.
Macchie fogliari
Diverse specie di funghi (come Cercospora, Phyllosticta, Septoria) possono causare macchie sulle foglie, che variano nel colore (marrone, grigio, nero) e nella forma, spesso presentando margini più scuri. A volte, il tessuto infetto cade, lasciando dei “buchi” sulla foglia.
Poiché non si tratta di un problema grave, basterà rimuovere e distruggere le foglie colpite.
Parassiti
Cocciniglia
Tra i parassiti più comuni, le cocciniglie si presentano come piccoli insetti spesso ricoperti da una corazza (cocciniglie cotonose, cocciniglie a scudetto) che si attaccano ai fusti e alla pagina inferiore delle foglie.
- Sintomi: produzione di melata (sostanza appiccicosa e zuccherina prodotta dagli insetti) e fumaggine (muffa nera che si sviluppa sulla melata), ingiallimento e deformazione delle foglie, crescita rallentata.
- Trattamento: rimozione manuale (se l’infestazione è limitata), spazzolatura, trattamenti con olio bianco o insetticidi specifici.
Afidi
Sono piccoli insetti verdi, neri o bruni che si raggruppano sui germogli teneri e sulla pagina inferiore delle foglie per succhiare la linfa.
- Sintomi: accartocciamento e deformazione delle foglie, produzione di melata e fumaggine.
- Trattamento: getto d’acqua forte, sapone di Marsiglia diluito, insetticidi specifici o introduzione di insetti ausiliari (coccinelle).
Cicalina dell’eleagnus (Cacopsylla fulguralis)
Questo insetto succhiatore può causare distorsioni e arricciamenti delle foglie, presenza di melata e conseguente sviluppo di fumaggine.
Nonostante l’aspetto sgradevole, raramente causa danni gravi alla vigoria della pianta di eleagno e spesso non richiede interventi specifici, poiché i suoi predatori naturali tendono a controllarne le popolazioni.
Problematiche fisiologiche
Ingiallimento delle foglie e disseccamento della pianta
Spesso non è una malattia, ma un sintomo di stress ambientale. Le cause possono essere:
- Carenza o eccesso idrico: sia la siccità prolungata che i ristagni d’acqua possono portare a questo problema
- Carenze nutritive: mancanza di ferro o altri micronutrienti nel terreno, specialmente in terreni molto calcarei, può portare a clorosi (ingiallimento delle foglie con nervature verdi)
- Eccesso di sali nel terreno: l’accumulo di sali può causare bruciature sulle punte delle foglie e ingiallimento
In generale, l’eleagnus è una pianta robusta che, se coltivata nelle condizioni appropriate (terreno ben drenato, esposizione adeguata e annaffiature moderate una volta stabilita), raramente incorre in problemi gravi. La prevenzione è sempre la migliore cura.