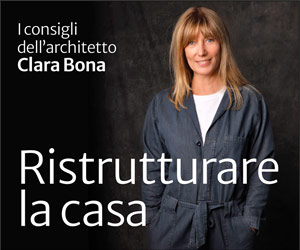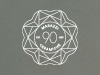Contenuti trattati
Ci sono alcuni accorgimenti per irrigare l’orto in estate in maniera corretta: bisognerà innanzitutto conoscere le esigenze degli ortaggi che abbiamo nell’orto e assicurare che abbiano acqua a sufficienza, poi è bene prestare attenzione alla temperatura dell’acqua e al metodo di innaffiatura per non rovinare gli ortaggi maturi. Le colture dell’orto devono essere irrigate regolarmente e con grande attenzione, soprattutto nel periodo estivo, per non rischiare di rovinare il raccolto o di danneggiare i frutti quasi giunti al momento della maturazione. Attenzione, infine, agli sprechi di acqua, un bene prezioso che è bene usare con parsimonia.
Temperatura dell’acqua
Un fattore di cui non si tiene conto abbastanza spesso è la temperatura dell’acqua, che dovrebbe essere simile a quella dell’acqua. Bagnare le piante con acqua fredda in una giornata torrida, infatti, può causare uno shock termico dannoso per le nostre piante. Per evitarlo sarebbe meglio non usare acqua che proviene direttamente dalle tubature della rete idrica, ma attingere da cisterne o bidoni dove l’acqua possa decantare e raggiungere la temperatura ambiente prima dell’utilizzo. Per innaffiare, l’acqua migliore è quella piovana, ma anche acqua sorgiva, di lago o di fiume, mentre la meno consigliata è quella proveniente dall’acquedotto, che spesso viene trattata con piccole quantità di cloro. L’utilizzo di bidoni e cisterne ha un ulteriore lato positivo: permette infatti di far evaporare l’eventuale cloro presente nell’acqua, che non fa bene alle piante. Un altro accorgimento utile per evitare shock termici è quello di bagnare l’orto o il giardino di mattina o di sera, nelle ore più fresche della giornata.
Quanta acqua serve per irrigare l’orto
Ogni orto e ogni giardino ha le sue esigenze specifiche in base al tipo di terreno, all’esposizione e a ciò che vi è piantato, ma nel periodo estivo le irrigazioni devono essere regolari e frequenti, anche più volte al giorno, in modo da non lasciare mai il terreno asciutto. Gli orari migliori sono al mattino presto e dopo il tramonto; bisognerebbe bagnare con un getto molto lento, in modo da raggiungere gli strati più profondi del terreno senza scorrere lontano dalle piante. Una buona alternativa è un impianto di irrigazione a goccia, che distribuisce l’acqua in maniera lenta e graduale, facilitandone l’assorbimento da parte dei vegetali. I fattori da valutare per decidere di volta in volta quanta acqua serve per irrigare l’orto sono principalmente:
- il clima e le precipitazioni: se ha piovuto da poco non serve irrigare;
- il tipo di terreno: un suolo sabbioso si asciuga più rapidamente e deve quindi essere bagnato più spesso, mentre un suolo ricco di humus resta umido più a lungo;
- le piante coltivate, ognuna con il suo fabbisogno specifico di acqua. In genere gli ortaggi piccoli hanno radici più brevi e quindi hanno maggiormente bisogno di acqua mentre quelle con un apparato radicale più sviluppano riescono a reperirla più in profondità. A fine ciclo, inoltre, spesso si tende a dare meno acqua per migliorare il sapore dei frutti che andranno raccolti a breve.
Tre sistemi efficaci
Quando le piantine sono già cresciute, la tecnica dell’annaffiatura a pioggia è sconsigliata perché la sua efficacia è limitata a causa dell’evaporazione e delle bruciature che l’acqua può provocare facendo effetto lente sul fogliame in presenza dei raggi solari. Le ferite che si possono vedere sulle piante ornamentali e che si considerano trascurabili negli ortaggi, incidono invece negativamente sulla capacità di fotosintesi della pianta e quindi sulla sua crescita e sull’accumulo degli zuccheri nei frutti.
Annaffiare con una canna a spruzzo o con gli irrigatori a pioggia comporta inoltre ingenti sprechi. In particolare:
- parte dell’acqua impiegata non cade all’interno dello spazio utile all’assorbimento perché viene portata via dal vento o perché gli irrigatori non sono calibrati con cura;
- parte dell’acqua, specie la prima, evapora a contatto di superfici calde o irraggiate dal sole, siano esse il fogliame, il terreno o le pietre del camminamento;
- l’acqua cade sul terreno, ben distribuita, è vero, ma in molti casi non riesce a raggiungere gli strati profondi del terreno, ma bagna solo i primi centimetri. Un tempo prolungato d’intervento non è garanzia d’efficacia, se il volume d’acqua distribuito per unità di superficie non è sufficiente a bagnare a fondo il terreno. A soffrirne sono, in periodo di reale siccità, soprattutto le colture con apparati radicali profondi e fittonanti o mediamente profondi.
Ci sono invece dei sistemi efficaci con cui procedere.
L’infiltrazione laterale
In questo caso l’acqua viene somministrata attraverso dei solchi che affiancano le piantine. Si immette l’acqua nei solchi grazie a una canna e si lascia correre fino a quando ha raggiunto la fine dei solchi, che sono ciechi, lasciandola assorbire lentamente. L’acqua bagna il fondo dei solchi e le pareti laterali interessando la zona di terreno esplorata dalle radici. Se tenuti puliti e dissodati con regolarità, i solchi permettono che l’acqua filtri lentamente fino a raggiungere l’apparato radicale.
Il tubo poroso o forato
Per le piante a grande sviluppo, tipo pomodori, zucchini e melanzane, l’irrigazione con tubo forato in corrispondenza delle radici è la tecnica più economica e razionale. Si tratta di un tubo che trasuda acqua o che la rilascia da più piccoli forellini e che deve essere collocato in prossimità del colletto delle piante. Il costante gocciolare crea un’area umida nella quale si sviluppano in modo preferenziale le radici. Questo sistema è da riservare alle colture di pregio, ai piccoli frutti, alle piante da siepe e agli alberi perché richiede un piccolo investimento iniziale, ma i risultati lo ripagano abbondantemente.
Il sistema a conche
Mutuato per gli ortaggi dalla tradizione degli agrumeti, consiste nello scavare intorno alle piante singole o a piccoli gruppi un leggero avvallamento nel terreno, attorno al colletto delle piante. Al momento dell’irrigazione, con la canna si allaga la conca e poi si lascia assorbire l’acqua lentamente. Le radici si svilupperanno nella zona mantenuta umida per diversi giorni. Con questa tecnica si interviene con meno frequenza, ma bisogna erogare una maggiore quantità d’acqua.

Per evitare la dispersione dell’acqua di irrigazione si possono effettuare delle piccole trincee intorno alle piantine affinché l’acqua non scoli lateralmente lasciando poco intriso il terreno.
Come non rovinare gli ortaggi maturi
Le piante, composte per l’80% circa di acqua, hanno bisogno di questa preziosa sostanza per tutti i loro processi vitali: per compiere la fotosintesi, per sviluppare radici, foglie e frutti, per prelevare nutrimento dal terreno e per molto altro ancora. È quindi importante che le irrigazioni siano sempre abbondanti e regolari, calibrate anche in base al tipo di piante che si sono coltivate, al momento dello sviluppo in cui si trovano e al periodo: se è vicino il momento di raccogliere i frutti della pianta, ad esempio, si può ridurre le annaffiature per concentrare i nutrimenti e migliorare il sapore dei frutti, rendendolo più intenso. È buona norma bagnare sempre nelle ore più fresche della giornata in modo che l’acqua non evapori immediatamente e che non crei un effetto lente, causando bruciature alla buccia spesso delicata dei frutti, oltre che alle foglie.
Come irrigare l’orto senza sprecare acqua
L’utilizzo razionale delle risorse, specie di quelle non rinnovabili come l’acqua, è motivo costante di attenzione da parte di tutti. L’acqua è un bene prezioso, il cui valore è destinato a crescere nel tempo, tanto che sono sempre più numerosi i progetti che vogliono potenziarne la captazione e lo stoccaggio e migliorarne la rete distributiva, minimizzando le perdite. Limitare il consumo di acqua quindi è necessario più che mai per l’ambiente, ma può avere anche interessanti risvolti economici, considerando quanto oggi pesino i costi delle utenze sul bilancio familiare. Un metro quadrato di terreno orticolo coltivato da aprile a ottobre in modo intensivo, sfruttando tutto il tempo e lo spazio disponibile, richiede un apporto idrico di 500-600 litri, vale a dire 0,5-0,6 metri cubi d’acqua. A questo dato possono essere sottratte le precipitazioni, ma soltanto quelle utili che possono essere calcolate con la quantità d’acqua trattenuta dal terreno. Ridurre gli sprechi e razionalizzarne l’utilizzo è possibile per tutti grazie ad alcuni accorgimenti che si possono mettere in pratica nell’orto.
Accumulare una riserva idrica
È una tradizione consolidata in aree siccitose, dove molte case dispongono di una cisterna d’accumulo privata. In gran parte del Nord Italia, invece, solo le case costruite negli ultimi dieci-quindici anni dispongono di un serbatoio interrato per la raccolta delle acque piovane operata dai pluviali. Per l’orto familiare, costituire punti di raccolta dell’acqua ha un duplice scopo: il primo è il risparmio, il secondo è quello di poter irrigare con acqua a temperatura ambiente, gradita agli ortaggi. Per costituire riserve d’acqua per l’orto si possono collocare in posizione di pieno sole alcuni vecchi fusti di metallo con una capienza di circa 200 litri, che verniciati a colori sgargianti possono aggiungere un tocco personale. Hanno un’apertura grande e possono raccogliere efficacemente la pioggia. Dopo la pioggia devono essere coperti, sia per minimizzare la perdita per evaporazione sia per impedire che possano cadervi dentro piccoli mammiferi e lucertole o che gli uccelli la imbrattino. A fine stagione i bidoni devono essere vuotati e capovolti, così che asciughino. È difficile che questi fusti si ribaltino, ma per sicurezza è meglio dotarli di una base in terra battuta e ghiaia oppure in terra battuta e lastre di pietra. Il contatto con un materiale drenante come la ghiaia e la pietra ne consente anche una maggiore durata nel tempo. I fusti devono essere posti in pieno sole, così che l’acqua possa riscaldarsi. Per chi ne ha la possibilità, un capiente serbatoio interrato che raccolga l’acqua dai pluviali è una garanzia di risparmio e ci libera dai divieti di innaffiare che a volte sono in vigore durante l’estate.

Ikon di Fitt è l’innovativo tubo estensibile, leggero e compatto che al passaggio dell’acqua si allunga di circa il doppio. Realizzato con tre strati in TPE, due intrecci interni di filato che ne controllano l’espansione e una copertura colorata resistente all’abrasione. Disponibile in 4 diversi colori e misure Ikon è dotato di pistola multigetto e raccordi, costa 25,90 euro per 10 m, https://www.fittgardeningideas.com

Molto pratico grazie al fatto che si aggancia direttamente al rubinetto e non richiede fori di fissaggio Space l’avvolgitubo è l’ideale per tenere in ordine il tubo dell’acqua e si adatta bene anche agli spazi ridotti. Ha dimensioni 10,4x12x26 cm ed è disponibile in diversi colori, di Bama costa 3,80euro https://www.bamagroup.com

Estremamente compatto e pratico il mini avvolgitubo AquaBag Style è ideale per irrigare piante, fiori e vasi su terrazzi, balconi e piccoli giardini. Equipaggiato con 11,5 m di tubo flessibile e 2 raccordi Soft Touch ad aggancio rapido, lancia ergonomica e presa rubinetto da ¾” si può usare appoggiato a terra o trasportato. Di GfGarden ha un design accattivante e costa 39,90 euro, https://www.gfgarden.it
Lavorare il terreno
“Una buona zappettatura val più di un’abbondante annaffiatura”: questa affermazione della tradizione popolare può lasciare scettici i neofiti, ma chi ha sperimentato la tecnica delle lavorazioni superficiali del terreno in periodo estivo, non può che attestarne la validità. Il terreno riscaldato dal sole perde acqua per evaporazione: l’acqua risale dagli strati profondi grazie alla capillarità e alla differenza di gradiente, così che non solo si asciugano gli strati superficiali, ma progressivamente si depauperano tutte le risorse idriche presenti nel terreno. La lavorazione superficiale, con interventi limitati allo strato non esplorato dalle radici, per non danneggiare le piante coltivate, riesce a interrompere la capillarità del terreno, impedisce la risalita dell’acqua dagli strati profondi e crea un elemento di discontinuità, una sorta di intercapedine arieggiata che riduce le perdite. La zappettatura superficiale ha inoltre il grande vantaggio di rompere la crosta che si crea per calpestio o per la pioggia battente. La crosta, infatti, favorisce il ruscellamento dell’acqua in superficie sia durante le piogge sia durante le bagnature, provocando inutili dilavamenti e impedendo l’assorbimento verso gli strati interessati dallo sviluppo delle radici. Allo stesso modo, le lavorazioni autunnali del terreno, decisamente più profonde ed eseguite con una vangatura, permetteranno al terreno di immagazzinare una maggior quantità d’acqua, che potrà risalire dagli strati profondi nei momenti di carenza.
Migliorare la tessitura del substrato
Gli ortaggi, per crescere con forza, richiedono un terreno ben drenato, non duro, fertile e ricco di sostanza organica. Tutti gli interventi che contribuiscono a creare queste condizioni consentono di ottimizzare gli apporti idrici. Il terreno non troppo compatto consente all’acqua di penetrare in profondità e di non ruscellare. La presenza di un buon contenuto in sostanza organica permette di accumulare acqua, perché le micelle dell’humus hanno la capacità di rigonfiarsi e trattenerla attivamente. I terreni argillosi trattengono molta acqua, ma si rivelano insidiosi perché diventano fradici, non sgrondano, favoriscono fenomeni di marcescenza e, con facilità, diventano freddi. In questi substrati troppo compatti si può aggiungere sabbia per migliorare il drenaggio e sostanza organica per migliorare la struttura. In più è importante variare ogni anno la profondità di lavorazione per non creare una “soletta” impermeabile che crei ristagni. I terreni sciolti e sabbiosi, al contrario, non trattengono acqua e si asciugano con facilità; in questi si può invece aggiungere sostanza organica sotto forma di letame e compost maturo, terreno di foglie e terricciato di concimi organici per migliorare sia la struttura sia la capacità di ritenzione idrica.
Attenzione alle malerbe
Le malerbe sono il nemico numero uno dell’orto perché sottraggono spazio, nutrienti, luce e soprattutto acqua: estirparle dalla radice regolarmente è quindi molto importante. Iniziano a vegetare quando le temperature sono ancora così basse da non permettere la coltivazione degli ortaggi estivi: le malerbe, infatti, crescono con forza, resistono agli sfalci, sviluppano apparati radicali estesi e vigorosi, si disseminano con facilità compiendo anche più generazioni in un anno. Approfittano di tutti gli spazi lasciati liberi nell’orto, dai camminamenti all’interfila, fra le verdure seminate a spaglio anche se fitte, alle zone in prossimità dei gocciolatoi o degli impianti idrici. Si tratta di piante con una gran massa vegetale, spesso con steli carnosi, costituita per il 90% d’acqua, pari in peso, se la valutassimo di volta in volta, dal 50 al 100% del prodotto raccolto. Ponendo attenzione a questi dati, è possibile capire quanto sia grande la quantità d’acqua che silenziosamente le malerbe sottraggono. Le erbe infestanti si combattono effettuando ogni 10 giorni circa sarchiature e zappettature nell’interfila e con la raccolta manuale all’interno delle aiuole, cercando di asportare anche gli apparati radicali. Questo intervento però non basta per eliminare le malerbe con apparato radicale profondo e fittonante, che devono essere estirpate, non per trazione, ma utilizzando una vanga o attrezzo apposito. Applicare una trazione forte e improvvisa serve soltanto a spezzare le radici, lasciando nel terreno una parte considerevole che può anche essere in grado di rigenerare l’intera pianta. La trazione deve essere sempre graduale, applicando la forza in modo progressivo a mano a mano che la pianta esce dal suolo.
Orto in estate, che cosa fare?
- Tutti i lavori del mese di luglio
- Nell’orto a fine estate si semina la cicoria da puntarelle
- Come curare la pianta di kiwi in estate